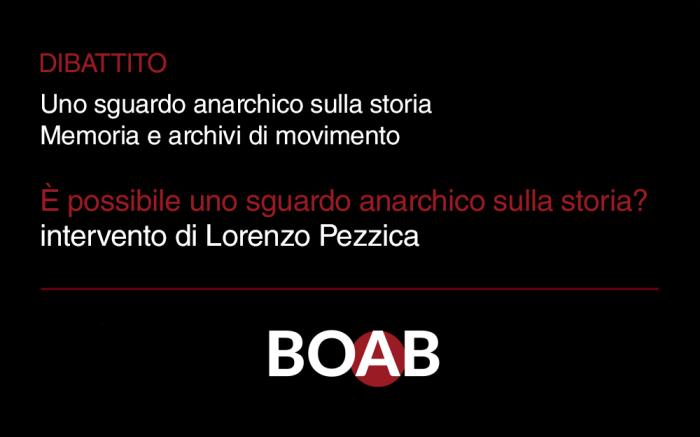Esiste ormai da tempo una rinnovata e consolidata storia e storiografia sull’anarchismo italiano e internazionale. Come accennato nell’editoriale di questo numero, già nel 2012 Ruth Kinna si domandava quali fossero gli elementi costitutivi della ricerca anarchica e di cosa avesse bisogno per essere pienamente adeguata ai suoi materiali di studio[1]. Non a caso la rivista inglese “Anarchist Studies” è tornata più volte su questa tematica, come testimoniano anche i contributi di Kathy E. Ferguson e Ian Forrest inclusi in questo numero del Bollettino ed entrambi originariamente pubblicati su quella rivista.
Nell’Introduzione a The Continuum Companion to Anarchism Kinna pone tre domande cruciali che di fatto ne sollevano molte altre: esiste la possibilità – o la necessità – di pensare a una specifica storiografia anarchica, ovvero una storiografia in grado di affrontare temi e argomenti storici anche al di fuori dall’ambito della storia anarchica propriamente detta? Esiste un approccio all’analisi storica che sia distintamente anarchico? Può questo approccio contribuire a discipline e campi di studio consolidati, e se sì in che modo? E infine, ha senso oggi proporre una “storiografia anarchica” o è meglio proporre un più aperto e meno strutturato “sguardo anarchico sulla storia”, inteso come pratica storiografica della ricerca tout court?
Proporre la questione in questi termini implica non solo portare avanti una riflessione prettamente storiografica, ma anche interrogarsi sul senso che oggi potrebbe assumere il mestiere dello storico.
Apro una breve parentesi. Il tema delle fonti – e quindi degli archivi – è certamente un tema non marginale in questa riflessione a tutto campo, e non riguarda solo gli archivi che potremmo definire tradizionali ma anche i “nostri” archivi, quelli che conservano “carte irrequiete”, ovvero più fluide, scomposte, fragili, lontane dai protocolli istituzionali. Un’irregolarità che a certe condizioni può diventare una forza anziché un limite e che ha messo in evidenza la necessità di ripensare lo statuto epistemologico dello stesso concetto di archivio[2]. Gli archivi di movimento in generale e i “nostri” in particolare hanno fatto emergere un bisogno fondamentale, quello di coniugare la forte tensione tra l’archivio come contenitore di memoria e l’archivio come strumento politico. Sono appunto questi gli archivi che hanno posto con forza la questione di trovare un punto di equilibrio tra la conservazione e l’attivismo archivistico della memoria proprio dei contesti militanti. Un equilibrio incerto che modifica la percezione quando questi archivi vengono digitalizzati e resi accessibili online; un cambiamento che potrebbe comportare il rischio di un loro appiattimento o che potrebbe al contrario aumentare la loro carica vitale.
Tornando alla questione principale, quella dello sguardo anarchico sulla storia, è interessante ricordare che nel 2013 e nel 2014 si sono svolti in Italia due importanti appuntamenti tra storici e storiche dell’anarchismo che hanno permesso di fare un primo bilancio sugli studi, i metodi e i temi della storiografia sull’anarchismo, così come si è configurata in Italia dal 1945 a oggi[3]. Da quegli incontri è emerso un quadro interessante – soprattutto per quanto riguarda la storia dell’Ottocento e del Novecento – di quelli che sono stati e sono i temi e i metodi principali della storiografia sull’anarchismo (che hanno peraltro prodotto numerosi studi). Temi che qui riassumiamo schematicamente perché possono rappresentare una base di partenza per cercare di rispondere alle domande prima sollevate. In sintesi, la storiografia dell’anarchismo non solo riconosce da sempre come suo aspetto caratterizzante la ricostruzione di singole individualità attraverso il metodo biografico, ma si è in specifico occupata dei seguenti temi: educazione; insediamento territoriale e forme associative e organizzative non gerarchiche; studio delle contaminazioni e ibridazioni culturali; analisi dei mestieri; circolazione delle idee, privilegiando un “metodo sincronico” della storia; emigrazione politica ed economica, con particolare attenzione alla questione dell’esilio; rapporto tra arte, letteratura e anarchismo; tematiche ecologiche; microstoria, con particolare attenzione alle comunità; ricostruzione del reticolo di relazioni informali, interpersonali e sociali, del movimento; centralità dell’azione dal basso e rifiuto della delega. Tutti temi che sottolineano il carattere transnazionale dell’anarchismo e che contestualmente richiedono metodi basati sulla ricerca d’archivio (fonte principale ma non unica) per lo studio delle diverse forme di anarchismo.
Sono sempre queste le tematiche e gli approcci metodologici cui ricorrere se si intendono affrontare periodizzazioni storiche diverse? Di certo, sono tematiche e metodologie di ricerca che possono, per esempio, incontrare l’approccio di una history from below, magari ridefinita e attualizzata rispetto alla proposta iniziale avanzata (in particolare, ma non solo) dallo storico inglese E. P. Thompson. Non a caso il nostro centro studi/archivio ha da molti anni adottato un metodo storiografico che privilegia la prospettiva offerta dalla “storia dal basso”. In questo senso, si è anche avvicinato alla Public History, sviluppando progetti a partire dagli stessi archivi che conserva e utilizza.
Per concludere, ha ancora senso oggi parlare di “storia dal basso”? E in che termini? Ma soprattutto, la “storia dal basso” può contribuire a definire ciò che intendiamo per “sguardo anarchico sulla storia”? La risposta è certamente affermativa, ma al contempo è necessario raffinare, sperimentandole concretamente nella ricerca, le pratiche storiografiche che consentono di fare storia orizzontale, ovvero di dar conto dei vissuti di quei singoli e gruppi che sono stati i veri protagonisti delle vicende storiche, pur rimanendo perlopiù sullo sfondo, se non del tutto anonimi. Va da sé che la capacità di ricostruire questi vissuti, tenendosi distanti dalle vulgate ufficiali e cercando di narrare “storie vive” di donne e uomini in carne e ossa, comporta una speciale consapevolezza, spesso occultata: la consapevolezza che il lavoro dello storico ha anche un valore politico, nel senso più esteso del termine. In ciò la nostra idea di “storia dal basso” si trova in sintonia con quanto da tempo sostiene Carlo Greppi nei suoi numerosi studi e in particolare nel recente storie che non fanno la Storia[4].
Un altro spunto interessante sulla storia dal basso (e forse altrettanto utile per quanto riguarda la questione dello sguardo anarchico sulla storia) lo si trova nel saggio di Simona Cerutti Who is below? [5], pubblicato nel 2015, nel quale la studiosa riflette su un possibile rinnovamento della proposta storiografica thompsoniana della history from below[6]. Un rinnovamento che passa anche dall’individuare un nuovo oggetto di studio anch’esso trascurato, dimenticato o sbrigativamente liquidato come i movimenti storici sconfitti o perdenti. Da questo punto di vista la storia dal basso diventa (anche) storia delle culture alternative, e si potrebbe aggiungere antagoniste e “rivoluzionarie”. Culture alternative e antagoniste che si sono espresse e si esprimono soprattutto (anche se non esclusivamente) attraverso movimenti collettivi di donne e uomini, tra i quali c’è lo stesso movimento anarchico. Non solo, ma attraverso un approccio che preveda anche l’antropologia storica, sarebbe in tal modo possibile allargarsi ad altre periodizzazioni della storia oltre a quella contemporanea (nel senso dell’Ottocento e del Novecento, dove hanno preso forma molti movimenti antagonisti), proprio nella prospettiva di uno sguardo anarchico su tutta la storia.
[1] Ruth Kinna (a cura di), The Continuum Companion to Anarchism, Continuum, New York, 2012.
[2] Di questi argomenti ho già trattato nel mio L’archivio liberato. Guida teorico-pratica ai fondi storici del Novecento, Editrice Bibliografica, Milano, 2020, e ne parlerò più diffusamente nel libro Carte irrequiete, di prossima pubblicazione per elèuthera, scritto insieme a Federico Valacchi.
[3] Si tratta del seminario Metodi e temi della storiografia sull’anarchismo (9 novembre 2013) e del convegno 150 anni di lotte per la libertà e l’uguaglianza. Per un bilancio storiografico dell’anarchismo italiano (10-11 maggio 2014), entrambi promossi dall’Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa e dalla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. Vedi https://e-review.it/bignami-metodi-e-temi-della-storiografia-sull-anarchismo; vedi anche Giampietro Berti, Carlo De Maria (a cura di), L’anarchismo italiano: storia e storiografia, Milano, Biblion, 2016.
[4] Carlo Greppi, Storie che non fanno la Storia, Laterza, Bari-Roma, 2024.
[5] Simona Cerutti, Who is below? E. P. Thompson, historien des sociétés modernes: une relecture, «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 2015/4, pp. 931-954. Un’interessante recensione è quella di Stefano Poggi, Per una nuova storia dal basso, Pandora, 2016 (https://www.pandorarivista.it/articoli/per-una-nuova-storia-dal-basso/).
[6] In sostanza viene avanzata una diversa proposta storiografica che intende recidere il legame primigenio della “storia dal basso” esclusivamente con la cultura popolare, in quanto viene ritenuto difficile, se non impossibile, stabilire una linea netta di confine fra cultura popolare e cultura alta, soprattutto nelle società moderne complesse.