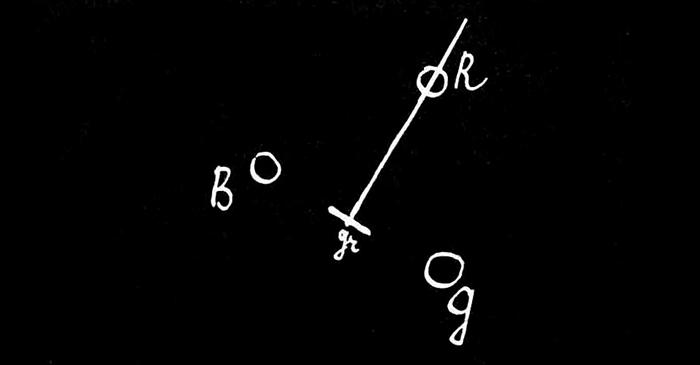Intervista a Jean-Pierre Duteuil raccolta a Parigi nel novembre del 1997
Estratto dell'intervista tradotto in italiano
Mi chiamo Jean-Pierre Duteuil e all’epoca del maggio 1968 facevo parte del collettivo «Noir et Rouge», poi sono stato membro del collettivo di «Monde Libertaire» e attualmente sono nell’OCL [Organizzazione comunista libertaria]. Mi occupo anche della casa editrice Acratie e partecipo al giornale dell’OCL «Courant Alternatif».
Cominciamo a parlare di Nanterre e di quello che è successo allora. Ma non si può parlare di ciò che è successo a Nanterre, precisamente nel maggio ‘68, senza risalire di uno, due, tre, quattro anni indietro, se non di più.
La specificità di Nanterre è che era il primo campus costruito in Francia fuori città. Dunque dal primo anno di università mi sono ritrovato a Nanterre al di fuori di tutta la vita urbana, sociale, non c’erano bettole, non c’erano cinema ecc. Era dunque una comunità costretta a inventarsi i propri spazi, che doveva sviluppare il suo sentimento di appartenenza, un luogo in cui non vi era interiorité.
E la stessa cosa valeva per la politica. Gli studenti non si trovavano in un’università classica, mancava un certo numero di strutture politiche... non vi era enquadrement [inquadramento].
L’università era stata costruita nel ’65 ed era il primo anno in cui funzionava la facoltà; e dunque gli elementi politicizzati di ogni tendenza – libertaria, di sinistra, ecc. – non avevano strutture già esistenti sul posto. Per un giovane, in quegli anni si offriva l’inconsueta possibilità di creare un certo numero di cose senza dover entrare in qualcosa di prestabilito.
Un altro aspetto particolare di Nanterre era che essendo una città universitaria le persone che vi abitavano, gli studenti che vi abitavano, non erano in generale dei parigini, ma persone che provenivano da ovunque. I francesi provenivano soprattutto dalla provincia, e dunque vi era uno spirito provinciale. Ma vi erano ovviamente molti stranieri, di tutte le nazioni, di tutte le razze, ecc.
Si costituì nella città universitaria una specie di melting pot culturale che dovrà sviluppare anch’esso, in questo luogo re lativamente freddo e neutro, un sentimento di appartenenza.
Questo era dunque il contesto: più che altrove, le persone si incontravano al di fuori dei corsi, nel campus, perché non vi erano molte altre cose da fare.
Un altro elemento importante cui accennare è anche quanto è andato accadendo nella città universitaria, ossia la mixité. È stato un avvenimento molto mediatizzato. Così era chiamata in generale l’occupazione degli edifici femminili da parte dei ragazzi, che spesso era presentata come una cosa un po’ triviale. Viceversa è stata una cosa molto importante perché si è trattato di una lotta che ha consentito di entrare in ogni momento nella cité universitaria. […]
In maniera accelerata, le persone quando avevano voglia di ottenere qualcosa, o di lottare contro qualcosa, hanno cominciato a ricorrere all’azione diretta, nel senso di fare direttamente le cose senza mediazioni, senza ricorrere ai funzionari o all’amministrazione. Poco formate, le persone non erano abituate alle relazioni di potere, alla negoziazione. Quindi, meno intermediari possibili e più azione diretta, occupazioni, ecc. […]
E noi del gruppo anarchico in prima linea con la volontà di fare innanzi tutto la critica dell’insegnamento.
Questa era una cosa relativamente nuova all’epoca, almeno nelle università, ma anche all’interno del movimento rivoluzionario degli ultimi cento anni. L’accesso all’insegnamento era comunque visto come un valore importante, uscito sia dalla Rivoluzione francese sia dalla laicità di un Jules Ferry. […] Il piccolo nucleo anarchico di Nanterre – un nucleo che va aumentando nell’ambiente universitario negli anni che vanno dal 1966 al 1968 – sviluppa questa critica a partire da discipline quali la psicologia, la filosofia, la sociologia, ma anche la storia, insomma le scienze umanistiche (all’epoca c’era il grande boom della sociologia americana, della psicosociologia al servizio delle imprese…). E così si arriva a fare un lavoro su queste tematiche: la critica dell’insegnamento, il problema della libertà nel senso ampio del termine, la libera circolazione delle persone, la sessualità, ecc.
J. Il tuo gruppo come si chiama?
D. All’epoca non ce n’è solo uno, ce ne sono parecchi. Il primo anno, a Nanterre, gli anarchici indicono una riunione, convocata tramite un annuncio su «Le Monde libertaire», per costituire un gruppo anarchico. Un gruppo studentesco è già stato messo in piedi da alcuni compagni della Sorbona, che a quel tempo è abbastanza di sinistra: è il gruppo Noir et Rouge, esterno alla Federazione anarchica francese, che conta al massimo una decina di persone.
Ci si vede molto spesso, si lavora... Lavoriamo anche nei sindacati, assieme ai trotzkisti dell’OCI, all’epoca chiamati lambertistes, in una corrente rivoluzionaria, ossia contraria all’integrazione dei sindacati nello Stato. Ben presto però ci separiamo da questa tendenza, con l’obiettivo di fondare una tendenza sindacalista libertaria. Il solo problema è che i compagni di Parigi non ci riescono, mentre noi a Nanterre ci riusciamo. Non perché siamo migliori, ma per quella specificità di cui ho parlato prima: perché è un luogo in cui è più facile sviluppare uno sentimento di appartenenza. Le persone sono più spinte a vedersi ed hanno uno spirito libertario più sviluppato e meno strutture attorno.
Molto rapidamente il nostro gruppo comincia a crescere, si lascia l’UNEF e si arriva ad avere un’autonomia di azione pur servendosi dei locali dei sindacati. Non siamo sindacalisti, ma lavoriamo un po’ in tutti i campi. Si organizzano conferenze sulla Rivoluzione spagnola, su Wilhelm Reich, si fanno riunioni e dibattiti sulle lotte operaie…
Ma bisogna anche notare che nei due anni che hanno preceduto il maggio ‘68 ci sono state un certo numero rivolte, di lotte operaie dure, in particolare nella regione atlantica. Ossia vi è l’arrivo sul mercato del lavoro dei giovani operai spesso usciti dall’ambiente rurale, che lasciano la fattoria e si ritrovano immersi nell’universo delle grandi aziende, all’epoca quelle della siderurgia e dell’automobile. Sradicati dall’ambiente d’origine, danno origi ne a un ambiente in parte ribelle perché le condizioni di lavoro sono abominevoli e il salario non molto elevato, ma in parte perché sono una massa di persone non inquadrate nel sindacato, che non hanno tradizioni sindacali. Scoppiano dunque, un po’ dappertutto in Francia, tutta una serie di scioperi violenti, con battaglie di strada, e al di fuori delle strutture sindacali. E questo, beninteso, ha delle ricadute anche all’università.
Comunque, il gruppo si chiama Liaison des étudiants anarchistes de Nanterre; è una struttura un po’ larga, anzi non è una vera e propria struttura. Ci si ritrova due, tre volte la settimana, si fanno azioni soprattutto in facoltà, ecc.
Così, a Nanterre, si costituiscono due gruppi importanti: la Jeunesse communiste révolutionnaire [JCR], il gruppo di Alain Krivine, all’epoca molto più a sinistra che attualmente, e gli anarchici.
A proposito di Nanterre, un’altra specificità del posto sono i rapporti politici tra i gruppi rivoluzionari. Sono, beninteso, rapporti conflittuali, ci si scontra, si dibatte, ci si affronta, ma ci sono anche rapporti affettivi e personali. Si è studenti anarchici, o ICL, o maoisti, ma si è anche di Nanterre. C’è un’appartenenza molto forte che può spiegare come poco dopo, nello spazio di due o tre mesi, il movimento 22 marzo supera le 142 persone che hanno occupato l’edificio amministrativo, arrivando infine a circa millecinquecentoduemila persone. […]
J. Che tipo di interventi vengono fatti?
D. Diverse azioni. Ad esempio, si entra durante le lezioni per contraddire i profes sori, per contraddire un certo numero di affermazioni su questo o quel soggetto, ecc. Vi è poi l’esigenza da parte dell’ambiente anarchico di difendere Daniel Cohn-Bendit, che è minacciato di sanzioni. Dani [Cohn-Bendit] non è francese e dunque può essere espulso. Ma anche altri sono espulsi dall’università. Dunque si crea un movimento per il diritto degli espulsi e ci si accorge allora che vi sono delle liste nere, che la direzione della facoltà ha delle liste con un certo numero di persone che sono i coordinatori.
Vi sono inoltre poliziotti in civile nella facoltà che scattano foto, sorvegliano... e il gruppo anarchico, sei mesi prima del maggio 1968, decide di reagire e prepara un’esposizione sui poliziotti in civile. Una mattina ci presentiamo con dei pannelli sui quali avevamo incollato le foto dei poliziotti in civile. Questo provoca un grande scandalo all’epoca, e il rettore chiama la polizia. È la prima volta che la polizia entra nei locali di un’università dopo... beh, dopo Vichy.
Ma i poliziotti che arrivano sono guardie, poliziotti comuni con manganelli, e non i CRS [reparti antisommossa] attrezzati come ora, e dunque si fanno buttare fuori dalla facoltà. È un avvenimento enorme (anche se in effetti non è che una magnifica azione).
Ma vi è un altro movimento importante nel contesto dell’epoca: ossia la guerra del Viet Nam. Un po’ ovunque in Francia l’estrema sinistra, anche quella libertaria, lotta e manifesta contro la guerra in Viet Nam, contro l’aggressione degli americani. Noi in quanto anarchici partecipiamo a tutto questo, ma non sulle posizioni dei comitati di sostegno. Partecipiamo contro la guerra degli americani, ma senza appoggiare il regime di Ho Ci Min. In questo contesto c’è una splendida azione promossa dalla JCR. All’Opera va un commando per diffondere volantini: trenta-quaranta persone di tutte le tendenze politiche che partecipano all’azione vengono arrestate. La sera stessa, durante un’assemblea generale, ci si ritrova in trequattrocento e si decide di occupare la torre dell’amministrazione. È il 22 marzo. Fissiamo un appuntamento alle sette di sera ai piedi della torre... e ci sono centoquarantadue persone che occupano gli uffici amministrativi fino a mezzanotte. All’epoca è un avvenimento del tutto nuovo, che potrebbe però passare completamente inavvertito... se i poliziotti non invadessero la facoltà. Diventa subito un grande avvenimento mediatico. Il giorno dopo chiudono la facoltà e noi ci riuniamo all’esterno organizzando forum su vari temi: i Paesi dell’est, le lotte operaie, la quotidianità, la sessualità... Centinaia di studenti partecipano ai forum. E tutto questo avviene prima del maggio 1968.
Il 3 maggio vi è un avvenimento: cinque persone dell’assemblea di Nanterre, tra cui io, devono passare davanti al Consiglio di disciplina dell’Università di Parigi. Dunque alla Sorbona.
Siamo cinque di differenti tendenze, c’è tutta l’estrema sinistra: due anarchici e un trotzkista per ogni famiglia trotzkista. Si invitano tutti a manifestare quel giorno ed è allora che ci sono i primi tafferugli di strada nel Quartiere Latino… il resto è ben noto. […]
Il maggio ‘68 rappresenta la fine di un periodo e l’inizio di un altro. E penso che sia così per tutti i grandi avvenimenti: ci sono degli elementi che ne mostrano la fine. Un elemento centrale è l’idea di rivoluzione. È un periodo in cui una parte della classe operaia, il PCF, una parte degli elementi che hanno fatto la resistenza, una parte dell’emigrazione spagnola, ha ancora l’idea di rivoluzione così come poteva essere intesa nell’immaginario del ’17 o del ’36: minoritaria, ma esiste (senza che tutti, beninteso, vi mettano dentro le stesse cose). Vi è ancora quest’idea e, in generale, ruota ancora attorno alla cen tralità della classe operaia. Nel ‘68 sono ancora presenti le concezioni tradizionali di classe operaia e tutti i rivoluzionari sono convinti che non si può fare la rivoluzione se la classe operaia non li segue, se non si muove. E sussistono tutte le articolazioni classiche, che per alcuni rimandano al sindacalismo, per altri alla costruzione del partito politico, e per altri ancora all’autogestione, all’organizzazione spontanea, ecc.
Ma ci sono cose che sono invece relativamente nuove (relativamente perché non dico che siano state inventate, o che non ci siano scritti in cui già si trovano queste cose, e tuttavia...). Certo, la rivoluzione... ma occorre anche cambiare subito delle cose. Non si può solo aspettare le Gran Soir (l’insurrezione). L’insurrezione è importante e necessaria, ci vuole la rottura, l’abbattimento dello Stato. Ma da subito, nella vita delle persone, nei rapporti tra le persone, deve cambiare un certo numero di cose. Questo è effettivamente una specificità del maggio ‘68: non perché non vi siano state altre persone che l’hanno detto prima, persino Marx, ma è la prima volta che massicciamente appare sotto forma di un movimento sociale.
Il maggio ‘68 non è evidentemente stato una rivoluzione, non c’è stata una presa del potere dal basso, realmente, in tutti i campi, e specialmente non nell’economia. Ma è l’emergenza di questa idea: che i rapporti sociali di ogni genere rivestono importanza nel processo rivoluzionario e che il processo rivoluzionario non è soltanto il cambiamento dei rapporti di produzione economica. Non sono idee nuove, ma per la prima volta vengono affermate in modo forte. Tutti questi elementi, infatti, li troviamo anche nelle rivoluzioni del ’17 o del ’36, anche lì sono indubbiamente successe delle cose. Ma non sono cose che gli storici o i militanti sottolineano. Quando si scrive la storia dei diversi movimenti insurrezionali o rivoluzionari questi aspetti sono passati relativamente sotto silenzio. Si trovano poche tracce, anche se siamo convinti che siano esistite... Ma per il ‘68 è difficile tralasciarli, passare sotto silenzio la profonda trasformazione dei rapporti tra uomini e donne, della sessualità, degli approcci culturali, dei primi interrogativi sulla finalità del lavoro.
E infatti fino ad allora il movimento rivoluzionario nel suo insieme, qualunque fosse la sua tendenza, valorizzava il lavoro. Vi era il mito dell’operaio che faceva qualcosa di utile, che era valorizzato dal suo lavoro. Era il suo luogo di socializzazione, era il suo luogo di appartenenza (e a mio avviso non si può fare la rivoluzione senza un’appartenenza). La collettività operaia era radicata su questo senso di appartenenza: l’abitazione, il quartiere, la bettola, il sindacato, il luogo di lavoro, ecc. E alla base vi era appunto l’idea che il lavoro era utile: era sfruttato, bisognava lavorare per se stessi, ma non se ne metteva in discussione l’utilità sociale. Il fatto di mettere in discussione la propria formazione, così come il tipo di rapporto che la società deve avere con il lavoro (da cui la problematica ecologica) è un fenomeno nuovo che non si afferma prima del maggio ‘68, ed è direttamente legato a questa rimessa in causa della finalità del lavoro.
J. A proposito della guerra del Viet Nam, vengono messe in questione anche le fabbriche di armi e questo genere di attività...
D. Certamente, anche se questo punto è relativamente meno nuovo perché gli anarchici sono sempre stati antimilitaristi. Vi sono molti scritti in cui si è sostenuto il rifiuto di lavorare nelle fabbriche di armi, anche se all’inizio del secolo c’era l’idea che ci si poteva impadronire delle fabbriche di armi per la nostra causa. Ma ora ci si rende conto che con le nuove tecnologie è molto poco probabile che il movimento operaio possa impadronirsene, e che sono comunque strumenti molto poco libertari. Vi è un tipo di tecnologia che non è utilizzabile altrimenti. Non basta impadronirsene per utilizzarla altrimenti. Questa è la vecchia idea positivista del XIX secolo, molto forte nel movimento anarchico, che non si è posto troppe domande sulle tecnologie. Ma nel maggio ‘68 noi e anche altri, in particolare i compagni italiani, abbiamo sviluppato una critica a tal proposito: vi sono tecnologie che in se stesse portano il potere, che non si possono rigirare.
Ma il maggio ‘68 è stato anche il rapporto uomo-donna, la sessualità, il riemergere di Reich. Reich viene rieditato: non bisogna dimenticare che all’epoca Reich era proibito e le edizioni erano edizioni pirata.
Ed è anche l’inizio della pillola, delle lotte per la pianificazione familiare, della rimessa in causa della tecnologia, e del fatto che cambiare la società non significa semplicemente cambiare i rapporti di produzione. Dunque non si può più parlare solo di lotta di classe, di lotta operaia punto e basta. E nel maggio ‘68 vi è un’esplosione di parole su tutte queste questioni.
Allora, si parlava giustamente di immaginazione al potere. Però bisogna diffidare un po’ degli slogan, perché a quel tempo vi era una grande abbondanza di slogan, di manifesti e di cose del genere, ma non possiamo non scorgervi l’emergenza dei media. All’epoca, anzi dai primi anni Sessanta, comincia la pubblicità, prende avvio il giornalismo investigativo, è l’inizio di quelle che sono ora le «prime pagine», e così via.
In effetti, tutti quegli slogan erano legati ad una realtà... e ciò che hanno fatto i media è stato di estrarli dalla realtà per farli diventare solo degli slogan.
Viceversa, vi era effettivamente molta immaginazione, anche se non in tutti i campi. Nel maggio ‘68 vi sono cose che sono restate molto tradizionali. Ad esempio, vi sono stati pochissimi tentativi di rifare dal basso l’economia, di produrre in altro modo, come ci sono molte poche rimesse in causa del Potere, se non appunto nell’immaginario. E questo perché, effettivamente, non è stata una rivoluzione.
J. Qual è stato il ruolo dell’anarchismo in quegli eventi?
D. È una questione complicata. In quanto tale, l’anarchismo organizzato non ha veramente avuto una grande influenza sul ‘68, a parte il caso specifico di Nanterre. Il movimento anarchico dell’epoca, dunque prima del ‘68, era più o meno nello stesso stato di quello odierno (anzi oggi va messo nel conto il riemergere della CNT [Conféderation Nationale du Travail, sindacato libertario francese]. In effetti non vi era che la Federazione anarchica francese, più o meno con lo stesso numero di membri di ora, e inoltre alcuni piccoli gruppi, riviste, ecc. Per contro, vi era effettivamente uno diffuso spirito libertario. In particolare, il movimento anarchico era assente dalle lotte operaie, se non per taluni gruppi sindacalisti in alcuni periodi e in certi luoghi (ma non necessariamente lì dove le cose si muovevano di più).
Perché bisogna ribadirlo: il maggio 1968 sono anche i dieci milioni di scioperanti. E non ci sarebbe stato quel maggio se non vi fossero stati dieci milioni di scioperanti per un mese... che è un numero enorme. Sono stati i lavoratori, soprattutto loro, che hanno fatto esplodere l’accordo sindacale. Il sindacato e lo Stato ci hanno impiegato dei mesi prima di arrivare a normalizzare tutto questo. E ciò è stato molto, molto importante. […]
Il ‘68 ha anche segnato la nascita di un nuovo movimento operaio. Nel maggio 1968 vi era un movimento operaio classico che si rifaceva all’inizio del secolo. Ma con l’afflusso di giovani non provenienti dalla tradizione sindacale e di giovani non classificabili come operai pur facendo parte del proletariato – come gli impiegati d’ufficio ecc. – avviene sul terreno delle lotte sociali l’incontro tra il movimento operaio classico e il nuovo movimento operaio. Che è appunto quello che definirà più approfonditamente gli anni che seguiranno il maggio.
J. E trent’anni dopo, che giudizio puoi dare.... Pensi che si possa parlare di un pre-maggio ‘68 e un post-maggio ‘68?
D. È molto complesso. Certamente il maggio ‘68 è l’inizio di un’epoca che durerà almeno una decina d’anni: tutto ciò che s’innesta nel maggio ‘68 arriverà ad una sua conclusione nel 1981, grosso modo. Se Mitterrand può installarsi al potere nel 1981, questa è incontestabilmente una conseguenza del maggio ‘68. Ma la cosa non poteva avvenire subito dopo. La borghesia ha aspettato che il movimento del maggio ‘68 decadesse per poter affidare il potere ai socialdemocratici. Farlo prima sarebbe stato molto più pericoloso.
Nel post-’68, grosso modo tra il 1977 e il 1978, vi è un numero incredibile di lotte in Francia, un numero di scioperi per anno molto elevato, ma anche di lotte su terreni non classici, dei nuovi movimenti: il Larzac, l’emergenza dell’ecologia, l’emergenza del movimento delle donne, l’emergenza del movimento antinucleare, la Lip,... Dunque, una serie di movimenti sociali, relativamente nuovi, che hanno portato avanti lotte molto dure. Anche se la Francia passa a lato della lotta armata, contrariamente alla Germania e all’Italia, vi è nondimeno l’idea che si vive in un periodo di scontro acceso. In questo sensi si può parlare di un post-’68 per rapporto a un pre-’68.
Tuttavia, questi nuovi movimenti sociali si ingarbugliano un po’, da una parte nella forza per la forza e dall’altra sui loro contenuti. E quando questi sono sempre più edulcorati, assorbiti il più possibile dalla restaurazione, beh, allora Mitterrand può arrivare al potere...