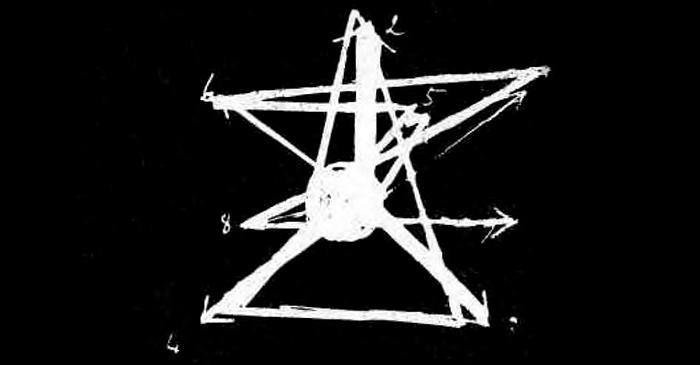Intervista a Edward Sarboni raccolta a Parigi nel novembre del 1997
Estratto dell'intervista tradotto in italiano
Mi presento: mi chiamo Edward Sarboni. Sono un militante della Fédération Anarchiste e attualmente, dopo il 54° Congresso di Rennes, sono anche segretario per le Relazioni Interne. È questo un mandato affidatomi dalla federazione tra due congressi. Per il resto, svolgo la mia militanza anarchica a Perpignan, dove risiedo, ed è là che io e le compagne e i compagni del mio gruppo esercitiamo il nostro talento di contestatori della società borghese, ben installata a Perpignan come altrove, in Francia, in Europa e a tutte le latitudini.
Il '68 è stato una rivoluzione? Vasta domanda! Perché se per rivoluzione si intende un qualcosa, un momento, che rimette in discussione i rapporti stabiliti dal processo di produzione e dalla produzione stessa, allora il '68 non ha modificato granché. Se invece si considera che una rivoluzione può anche comportare cambiamenti profondi sul piano culturale, sul piano dei costumi ed anche sul piano politico – nel senso originario del termine – si può allora rispondere affermativamente: il '68 è stato in effetti un momento di grande contestazione.
La prima di queste contestazioni è stata la rimessa in discussione, da parte di una gran parte della gioventù, dei modelli di società fino ad allora imposti dagli adulti. È bene aprire qui una parentesi citando l'esempio degli Stati Uniti: questa contestazione arrivava dal Nuovo Mondo – e già da tempo, dalla fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta – e rimetteva in discussione un po' tutte le mode culturali imposte dal mondo capitalista. Infatti, quando il Maggio '68 scoppia in Francia, esso è effettivamente animato da una gran parte della gioventù: la gioventù studentesca, cui rapidamente si aggiunge la gioventù operaia, la gioventù delle fabbriche. Io stesso all'epoca lavoravo già e per me il '68 è stato la scoperta del movimento anarchico, poiché – come tanti altri – cominciavo a vedere apparire, nelle varie manifestazioni quotidiane, delle bandiere nere. Il '68 è stato perciò un grande momento di risveglio.
Parlavo della gioventù: è un elemento importante perché, se si vuole considerare il Maggio '68 una rivoluzione, quello è stato un momento che ha rivoluzionato i modelli culturali e anche l'immagine che la gente si è fatta della società in cui vive e della società in cui vorrebbe vivere. Per esempio, nel '68 i giovani erano stufi della società che gli adulti proponevano, una società fatta di gerarchie, di responsabilità basate su rapporti d'autorità, ed infatti hanno contrapposto molto rapidamente modelli culturali diversi. A livello dei costumi, c’è evidentemente stata una rimessa in discussione piuttosto profonda della famiglia, dei rapporti personali, e si è vista emergere, per esempio, una contestazione da parte delle donne, contestazione fino ad allora inesistente. Il problema del posto della donna nella società si era presentato, naturalmente, molto prima del '68, ma si deve molto al Maggio '68 per averlo posto sul piano culturale.
Ma di fatto tutti i concetti borghesi, autoritari, proposti dalla società, da tutte le società stataliste, venivano rimessi in discussione, perché la domanda che molto spesso veniva alla mente della gente era: “Siamo qui per lavorare, ma perché lavoriamo? Per fabbricare cosa? Che genere di merce? Qual è il nostro posto nel processo di produzione? Abbiamo realmente peso? Decidiamo qualcosa?”. Tutto ciò ha fatto sì che per molti il Maggio '68 ha preso, sotto certi aspetti, un andamento rivoluzionario. E mi sembra un aspetto importante che spesso è stato tralasciato: i sociologi, per esempio, hanno affrontato il problema, ma di fatto hanno concluso, un po' troppo rapidamente – e forse in modo deliberato – che il'68 non è stata una rivoluzione in quanto non ha rimesso in discussione gli elementi contestabili della società in termini di produzione e di sfruttamento. Ma il '68 ha rimesso in discussione proprio quel modo di analizzare la società. L'uomo è un “homo faber” – sosteneva il marxismo – con una capacità quindi di contestazione, ma unicamente nel processo produttivo. E se invece, come sostenevano gli anarchici nel XIX secolo e come ha poi sottolineato Marcuse, la dimensione dell'uomo rimandasse a quella di “homo ludens”? Ciò vuol dire che, accanto al posto che occupa nella produzione, ci sono anche i suoi desideri, la sua volontà di vivere, di vivere le sue passioni ed eventualmente di viverle con altri. Questo è per me il punto forte del ‘68: da quel momento non si possono più guardare le cose come prima e questo è importante.
Quando si parla del '68, c'è qualcosa che mi viene in mente, qualcosa che in realtà viene in mente a molte compagne e compagni, ovvero che il '68 è stato effettivamente una rivoluzione. Anzi, sono convinto che si possa affermare che se il ‘68 è una rivoluzione, nella misura in cui ha messo in discussione i processi culturali a livello delle relazioni, dei costumi, del posto degli individui nella società, essa è stata una rivoluzione libertaria in senso lato. Una rivoluzione intimamente libertaria.
Ciò detto, mi pongo un'altra domanda: gli anarchici sono stati protagonisti di questa rivoluzione oppure le sono andati dietro o addirittura l’hanno subita? Subita, non penso proprio. Non credo che un solo anarchico l'abbia subita. Ma gli anarchici hanno fatto come tutti: l'hanno vista arrivare. Non penso che l'abbiano prevista, non più di chiunque altro, ma non l'hanno subita, nel senso che il '68 riprendeva davvero le idee, le convinzioni intime di questo movimento: non potevano quindi subirla. Risulta altrettanto evidente che non ne sono stati i protagonisti, è vero. Questa, però, è una prima risposta: gli anarchici le sono andati dietro, cercando – nei momenti e nei luoghi opportuni – di portare i discorsi e le proposte anarchici, per supportare questa volontà generale di capire la società con uno spirito nuovo e cercare di proporre soluzioni nuove per la società futura.
Gli anarchici hanno dunque occupato questo posto, ma una volta detto questo, si è detto tutto e niente. Dal punto di vista organizzativo, gli anarchici erano pronti a sussumere il movimento del ‘68? Penso di no. Perché no? Perché se si formula meglio la domanda – ovvero: “Gli anarchici erano pronti dal punto di vista organizzativo? I mezzi che permettono ad una rivoluzione di mettersi in marcia e diffondersi erano nelle mani degli anarchici?” – sinceramente la risposta è no. Se mi si chiedesse se le riflessioni e le proposte anarchiche erano sufficienti, importanti, risponderei di sì, ma il problema era che bisognava dare risonanza alle rivendicazioni che emanavano dalla base, nel senso profondo del termine, dagli individui che cominciavano a prendere la parola. Il '68 è stato un momento intenso di presa di parola da parte di molti.
Gli anarchici avevano le loro organizzazioni. Nel ‘68 c'era la Fédération Anarchiste, che esisteva dal 1954-55 e che aveva un organo di stampa all'epoca mensile, “Le Monde Libertaire”, lo stesso giornale e la stessa organizzazione di oggi. Poi c'era l'O.R.A. [Organisation révolutionnaire anarchiste], che esisteva già ma al tempo come un’organizzazione interna alla Fédération Anarchiste. All’epoca non era ancora un’organizzazione a sé. C'era poi una sfilza di piccole organizzazioni, come ne abbiamo sempre avute e come ne avremo sempre nel movimento libertario. Queste organizzazioni erano effettivamente molto minoritarie all’interno della classe operaia, molto minoritarie nel paese. Ripeto, non lo erano in rapporto alle proposte che facevano, ma lo erano numericamente e nella capacità di far cambiare le cose. Per fare un esempio: nel '68 avevamo solo un mensile. Un settimanale è più difficile da gestire, ma esso consente di fornire indicazioni sulle pratiche in corso. Un mensile non può intervenire se non sulle questioni di fondo, sull’ideologia o sulle proposte generali… molto più difficilmente sull’incidenza di questo o quell’aspetto della lotta. E non avevamo neppure un quotidiano, avevamo solo un mensile (uso il noi anche se all’epoca non ero ancora nella Fédération Anarchiste, alla quale ho aderito nel '68). Malgrado ciò, il '68 ha permesso alla gente di avvicinarsi all’anarchismo, di conoscere le sue idee e il suo movimento, anche se dal punto di vista organizzativo le capacità erano ridotte.
Un altro esempio è Radio Libertaire. Se ricordo bene ciò che succedeva nel ‘68, le radio, come RTL o Europe 1, si comportavano praticamente come le radio libere che abbiamo conosciuto in seguito, e questo spiega un po' il senso profondo del '68. In altre parole, i responsabili dell'informazione – non tutti vecchi, c'erano già dei giovani – sono stati colpiti dalla profondità di quel movimento, dalla sua intensità, e in effetti facevano da radio libere, cioè davano la parola senza censura, senza mentalità poliziesca. Per esempio, organizzavano dibattiti tra il rettore dell’università e Dany Cohn-Bendit o [Jacques] Sauvageot o [Alain] Geismar, che erano gli esponenti più in vista del movimento studentesco. Quel che voglio dire è che se avessimo avuto Radio Libertaire allora… che formidabile mezzo sarebbe stata! Avremmo avuto la radio giusta al momento giusto, cioè una radio che non intendeva fare da stampella a un qualsiasi movimento che chiedesse semplicemente di avere la parola, perché Radio Libertaire, e tutte le radio libertarie del mondo, quando danno la parola, lo fanno perché questa parola sovverta a fondo la società. Cosa facevano invece i giornalisti di Europe 1 o di RTL? Mettevano un po’ di sovversione nel loro lavoro, ma non nella società. Di fatto, tutto avveniva nella forma ma non nella sostanza.
Ecco quindi due o tre elementi che permettono di dire che il '68 ha trovato tutti gli anarchici pronti a dire “presente”, ma non ha trovato il movimento, sempre che qualcuno lo stesse cercando. O meglio, non ha trovato quel movimento che permettesse di amplificare ciò che si stava mettendo in marcia. Penso che tutto questo la storia lo abbia mostrato.
In genere, nei libri sul ‘68 scritti da storici e sociologi, ma anche dagli stessi protagonisti e protagoniste, si relativizza il posto che noi anarchici abbiamo avuto, e ritengo che questo sia molto logico: è una questione di etica e di umiltà. Comunque sia, abbiamo usato tutti i mezzi di cui disponevamo all'epoca: non si poteva fare di più, e naturalmente ce ne rammarichiamo. Per contro, ci sono parecchie correnti politiche che rivendicano per sé, e a torto, il '68, ma questa è un'altra storia di cui qui non parleremo.
In conclusione, ho cercato di definire il mio ’68 – rivoluzione/non rivoluzione –apportando qualche informazione in più sul ruolo delle organizzazioni anarchiche nel Maggio '68. In realtà, per essere più esaurienti sull'apporto di queste organizzazioni, non si può non parlare di un fenomeno ben preciso, che riprende elementi propri dell'azione anarchica. Ovvero possiamo considerare il '68 come una rivoluzione se ci soffermiamo su alcuni aspetti particolari. Mi riferisco soprattutto al movimento comunitario, o meglio alla nascita di comunità libertarie, perché di questo si trattava: di comunità libertarie che hanno cominciato a costituirsi a partire dal '68. Ritengo che si possa dire – ho fatto uno studio sulle comunità –che dal '68 al '78, per una decina d'anni, abbiamo assistito a un fenomeno di creazione di collettivi, o meglio di vere e proprie collettività di tipo sia anarchico sia libertario. E prima di entrare nei dettagli, penso sia importante dire che, nella misura in cui il '68 ha sollevato questioni che hanno rimesso in discussione i modelli culturali e i rapporti interpersonali, questo fenomeno delle comunità libertarie è stata una delle risposte più conseguenti di quel movimento. Dire ciò è un'ovvietà. Ma a questo punto bisogna volgere lo sguardo al passato: ci sono stati tentativi di costruzione di comunità anarchiche? Penso a un tentativo piuttosto illuminante: la Colonia Cecilia in Brasile, dove alcuni compagni anarchici hanno messo in pratica per alcuni mesi una quotidianità, una modalità esistenziale, libertaria e collettivista.
Quando in Francia si sono costituite queste comunità – soprattutto nel sud e nel sud-ovest, ma anche nelle Cevenne, nelle Alpi dell'Alta Provenza e in Provenza –possiamo supporre che queste conoscessero cosa fosse stato realizzato in passato. Bisogna dunque parlare di memoria, di ciò che ci insegna la storia. In effetti, le comunità anarchiche e libertarie costituite nel mondo, e in particolare in Francia all'inizio del XX secolo e fino agli anni Venti (penso a quella di Coissac, dal nome di uno dei suoi fondatori), hanno lasciato delle tracce e hanno permesso ai giovani contestatori del ‘68 di applicare la contestazione della società a una pratica del quotidiano. Che cosa hanno fatto? Sono semplicemente partiti. Hanno lasciato il loro domicilio, cioè il modello familiare che contestavano e che non volevano ricreare altrove. Questa contestazione toccava l'individuo, sessualità inclusa. Nel senso che quando qualcuno arrivava nelle comunità, uomo o donna che fosse, il problema non si poneva: tutti loro volevano essere i protagonisti della propria vita. Così un secondo tabù veniva in qualche modo infranto: quello della coppia in un primo tempo e, in un secondo tempo, quello – spesso collegato – della proprietà: mia moglie, mio marito, il mio uomo, la mia donna…
Un terzo elemento nuovo, in queste comunità, era il fatto che il denaro messo in comune poteva provenire da fonti diverse: per esempio, qualcuno o qualcuna poteva lavorare all'esterno. ![]() Non c'era dunque un taglio netto con il mondo capitalista, poiché queste persone ne subivano lo sfruttamento, ma quelli che ricevevano un salario potevano versarlo nelle casse della comunità, e così questo apporto finanziario che arrivava all’intera comunità permetteva di creare qualcos’altro, qualcosa non per perpetuare la società capitalista, ma per contestarla nell’immediato, nel quotidiano. C'erano anche altri modi per far entrare denaro nella comunità: l’autoproduzione della comunità stessa, che poteva attuarsi sul piano agricolo (e bisogna ammettere che raramente funzionava) o sul piano artigianale: fabbricazione di capi di abbigliamento, di gioielli, di oggetti di cuoio, tutto quello insomma che rientra nell’artigianato e che può stabilire un nuovo modo di produzione non dominato dallo Stato.
Non c'era dunque un taglio netto con il mondo capitalista, poiché queste persone ne subivano lo sfruttamento, ma quelli che ricevevano un salario potevano versarlo nelle casse della comunità, e così questo apporto finanziario che arrivava all’intera comunità permetteva di creare qualcos’altro, qualcosa non per perpetuare la società capitalista, ma per contestarla nell’immediato, nel quotidiano. C'erano anche altri modi per far entrare denaro nella comunità: l’autoproduzione della comunità stessa, che poteva attuarsi sul piano agricolo (e bisogna ammettere che raramente funzionava) o sul piano artigianale: fabbricazione di capi di abbigliamento, di gioielli, di oggetti di cuoio, tutto quello insomma che rientra nell’artigianato e che può stabilire un nuovo modo di produzione non dominato dallo Stato.
Questo tipo di attività tendeva effettivamente ad aggiungere una nuova dimensione alle comunità di spirito libertario, ovvero mettere in comune e gestire collettivamente le risorse più varie, comprese quelle finanziarie, senza che ovviamente la persona che apportava un contributo potesse per questo avere un qualche potere o un qualche ruolo gerarchico. E qui c’è un altro aspetto nuovo: la ferma volontà di funzionare in modo egualitario all'interno della comunità. Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare. Ne vorrei fare un altro in campo culturale e relazionale: in moltissime comunità i figli di una coppia diventavano in qualche modo i figli della comunità. L’educazione dei bambini non era cioè appannaggio dei genitori, altrimenti sarebbe stata una replica del modello familiare di tutte le società capitaliste e patriarcali. Al contrario, lì nascevano rapporti interpersonali del tutto nuovi. Ciò detto, bisogna anche chiedersi con grande onestà: tutte queste proposte e realizzazioni comunitarie hanno dato risultati tangibili? A mio avviso, sì. Effettivamente tutto ciò ha provocato una grande contestazione individuale e collettiva nelle persone che vivevano in quelle comunità. Ma anche al di là, poiché queste comunità si insediavano in luoghi precisi, e i paesani o i cittadini (perché esistevano anche comunità urbane) entravano in contatto con loro, con questi comunitari-collettivisti (che in campagna chiamavano hippies e nell'Ariège anche capelloni o beatniks), e vedevano non solo come vivevano e come si divertivano (non essere tristi è fondamentale) ma anche come apportavano – perché non era soltanto qualcosa di ludico – elementi di contestazione nei confronti della vita in società. Al tempo stesso, erano persone che non riproducevano obbligatoriamente un modello del tutto diverso da quello di chi viveva loro accanto. Voglio dire che i comunitari cercavano di incontrare gli autoctoni, la gente dei villaggi e delle città in cui si insediavano, e tutto ciò ha avuto delle conseguenze. Per esempio la nascita della contestazione femminista. Nel modello comunitario, la donna diventava un individuo a parte intera, sotto ogni punto di vista: nei rapporti interpersonali, nei rapporti amorosi, nei rapporti con i bambini, nelle modalità di funzionamento materiale, economico, di quelle entità collettive. E sono convinto che tutto ciò abbia suscitato la volontà di tradurre questa contestazione in un movimento femminile autenticamente femminista.
In conclusione, è certo che tra il '68 e il '78 sono esistite molte comunità, che si sono oltretutto incontrate tra di loro. Questi incontri riguardavano in particolare le comunità che si richiamavano all'anarchia. Uno studio di inizio anni Settanta, pubblicato su “Le Monde”, riportava una statistica secondo la quale in quelle comunità, durante l’estate, vivevano circa 100.000 persone. Chiaramente, il periodo estivo permetteva alle persone che abitavano nel nord della Francia o dell'Europa di andare a sud. Ma se questo è vero, in ogni caso durante i rigori dell’inverno molti restavano nelle comunità, quindi non si può dire sbrigativamente che fosse solo un modo economico di passare le vacanze al caldo. C’è stato veramente un movimento importante e diffuso che è sicuramente stato un'emanazione concreta del ‘68.
Dopo il '78, questo movimento – che è andato avanti per una decina di anni, con picchi e ricadute, momenti di progresso e di regresso – ha continuato a esistere? Io penso di sì, ma sotto altre forme. Dalle comunità libertarie o anarchiche, si è infatti passati ad un'altra maniera di funzionamento, chiamata “alternativa” (e di conseguenza coloro che la praticavano venivano chiamati “gli alternativi”).
Se si parla di '68, bisogna anche parlare della rimessa in discussione dei valori borghesi anche nel modo di comprendere la delinquenza e la devianza sociale.
I compagni italiani in questo campo erano in anticipo (ma questa preoccupazione esisteva anche in Francia, in Germania, in altri paesi europei e negli stessi Stati Uniti) e avevano fornito un certo numero di risposte sui modi in cui trattare la problematica della devianza sociale, un problema che si era posto anche nelle comunità. Nella regione di Nîmes, per esempio, esisteva una comunità che accoglieva un certo numero di “devianti”, e quindi la comunità, al di là della sua specificità, gestiva anche “altro”, diventando un luogo di risoluzione di problemi. Chiudo questa parentesi, dicendo che in effetti qualcosa di tutto ciò è rimasto anche dopo il '78.
Quelli che venivano chiamati “luoghi di vita” erano dunque nati – possiamo dirlo – dalla tradizione del ‘68 e dalla tradizione comunitaria. In altre parole, una micro-società nasceva non perché proclamava: “Bisogna vivere in micro-società”, ma perché costruiva un insieme in cui i rapporti interpersonali diventavano rapporti liberati, per non dire libertari, ovvero rapporti che permettevano sul piano “terapeutico”, con tutte le virgolette del caso, di gestire proprio le devianze ed i casi che non potevano essere assunti dalla società, quale essa è e quale noi la conosciamo.
Si vede quindi come – di riflesso – il '68 sia andato molto lontano. Potrei dire, per terminare, che il fatto che se ne parli ancora – anche se si tratta ormai di trent’anni fa – significa che il '68 è stato un'onda lunga, qualcosa di profondo di cui non si sono ancora scoperte tutte le tracce, tutti i segni lasciati negli individui: tanto meglio!
Di sicuro, non penso che una giovane donna di oggi rifletta su certi problemi come si faceva un tempo: c’è un avanti '68 e un dopo '68. Ecco.