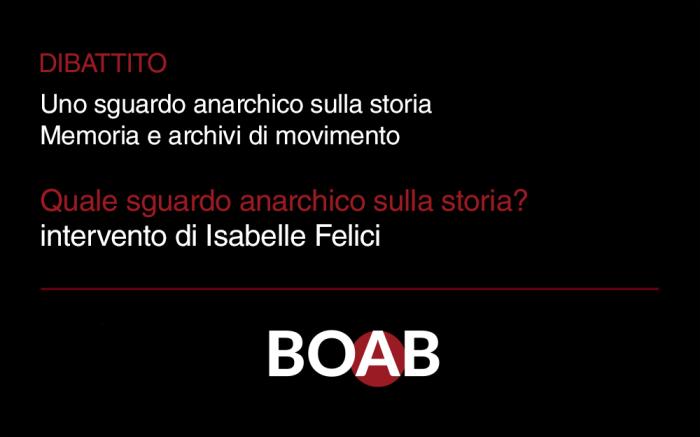Quale sguardo anarchico sulla storia?
di Isabelle Felici
Per contribuire alla riflessione sull’esistenza di uno sguardo anarchico sulla storia, propongo di fare un passo indietro e interrogarci sulle nostre pratiche di ricerca. Per quanto mi riguarda, dato che non sono arrivata alla storia dell’anarchismo tramite l’anarchismo, ma attraverso i fenomeni migratori, è con la massima cautela che propongo alcune piste di riflessione, tanto più che il mio percorso di formazione non è passato inizialmente per il campo della storia, ma per quello dell’italianistica, nel quadro dell’università francese. Ho acquisito così il gusto e la pratica dell’analisi testuale, che continuo ad applicare ai miei oggetti di studio. Aggiungo che, pur non appartenendo a nessuna corrente militante, ho potuto avvicinare un numero sufficiente di persone coinvolte nel movimento anarchico, presente e passato, per raccogliere una varietà di definizioni su ciò che potrebbe essere uno “sguardo anarchico”, fino a potermi arrischiare a formulare una mia propria definizione. Infine, dato la lontananza geografica da quasi tutti i miei oggetti di studio, la necessità di avvicinarmi mi ha portata a sviluppare capacità linguistiche e relazionali che hanno in parte compensato la distanza. A partire da queste posizioni, e prendendo spunto da esperienze passate, sono qui proposte alcune suggestioni, piste di riflessione, destinate ad alimentare il dibattito su quello che potrebbe essere uno sguardo anarchico sulla storia.
Avendo scelto di studiare la presenza degli anarchici italiani in Brasile attraverso la stampa, non avevo previsto di occuparmi di un tema che consideravo come la semplice “pre-istoria” del mio argomento principale, ovvero l’esperienza comunitaria fondata in Brasile poco prima della pubblicazione dei primi giornali anarchici italo-brasiliani: la colonia Cecilia (1890-1894). Devo dunque al caso l’aver cominciato il mio percorso di ricerca con quello che si è rivelato essere un oggetto ideale per muovere i primi passi: una bibliografia ricca e variegata, in diverse lingue (italiano, portoghese, francese, tedesco), fonti archivistiche (nelle stesse lingue e sparse in tutto il mondo), numerose produzioni culturali (canzoni, letteratura, teatro, cinema) che ne traggono ispirazione, la memoria di testimoni diretti o indiretti e, soprattutto, un enigma da risolvere a causa delle molteplici contraddizioni che emergono dalla lettura di diversi lavori di storici o sedicenti tali.
Da questa esperienza di ricerca, durante la quale è stato necessario distinguere il vero dal falso, risalire alla fonte degli errori, delle tensioni, delle interpretazioni, e per la quale è stato necessario trovare il tono giusto nel confrontarsi con ricercatori allora molto più esperti di me, emerge una sola regola: verificare sempre le fonti e non mancare mai di citarle. Dato il semplice buon senso di questa regola, ci si stupisce che non venga applicata sistematicamente e che sia addirittura necessario ricordarla. Purtroppo non mancano le occasioni che confermano la necessità di questo richiamo. A volte basta un piccolo dettaglio per gettare un velo di dubbio su un intero lavoro, ad esempio quando si constata che un’opera di finzione letteraria viene utilizzata come fonte documentaria o quando l’interpretazione di una determinata citazione viene scelta non in base al suo contesto, ma in funzione di una figura anarchica di cui bisogna a tutti i costi preservare l’immagine, anche al prezzo di una distorsione. Si arriva così a un primo elemento di definizione dello sguardo anarchico: un atteggiamento rigoroso e onesto come unico mezzo per evitare distorsioni, ad esempio quando ci si trova di fronte a un epistolario incompleto, a una collezione di periodici a cui mancano dei numeri, alla traduzione manifestamente carente di un documento originale che è andato disperso, all’edizione di un testo non revisionato dalla persona che l’ha scritto, a una citazione riprodotta male o fraintesa… Al buon senso si aggiunge quindi una forma di umiltà, perché siamo tutti e tutte sempre in balia di un errore.
Siamo anche tutti e tutte soggetti al rischio di lasciarci trascinare dall’emozione e dall’attaccamento al nostro oggetto di studio. Nel caso della storia dell’anarchismo, questo rischio è accresciuto dalla forte presenza militante tra chi porta avanti le ricerche. Allo stesso tempo, questa forte presenza militante offre, il più delle volte, un enorme vantaggio: il senso di condivisione. Infatti, la pratica della scienza aperta si è sviluppata negli ambienti anarchici prima che diventasse di moda nel mondo accademico. Nonostante la difficoltà delle relazioni interpersonali che rallentano e complicano inutilmente il processo, nonostante la diffidenza che le tecnologie più recenti ispirano ancora in alcune persone (si attribuiscono agli altri le malefatte che si sarebbe capaci di commettere), nonostante il mantenimento di un forte gusto per la carta, che non implica, al contrario, che si debba ridurre l’uso di altri mezzi di comunicazione, la conservazione e la diffusione hanno fatto passi da gigante negli ultimi decenni. Alcune anomalie devono ancora essere corrette, ad esempio quando il catalogo digitale di un archivio o di una biblioteca è incompleto, inutilizzabile o addirittura inesistente. Bisogna però lodare l’esemplarità con cui alcuni centri di documentazione riescono a passare il testimone, a evitare l’insidia dell’intorpidimento e a ignorare le incomprensioni intergenerazionali. La quantità di energia impiegata è immensa, commisurata agli ostacoli da superare. Oltre alle difficoltà finanziarie, tecniche e organizzative, è forse sul piano linguistico che resta ancora molto da fare per facilitare ulteriormente gli scambi e superare le barriere che persistono tra le aree linguistiche. Poiché i nostri oggetti di studio hanno spesso dovuto ignorare i confini, non c’è dubbio che potremmo imparare di più dalle pratiche del passato, le cui implicazioni linguistiche devono ancora essere studiate.
Questa definizione, metodologica e non teorica, dello sguardo anarchico sulla storia può essere facilmente applicata con profitto ad altri oggetti al di fuori della storia dell’anarchismo. Da parte mia, ho constatato come il mio sguardo sui fenomeni migratori e sulle loro rappresentazioni culturali si sia arricchito grazie alle ricerche sull’anarchismo italiano fuori d’Italia, e viceversa. Di fronte ai numerosi conflitti e dibattiti che circondano la questione migratoria, ho imparato a sfuggire alle categorizzazioni e alle semplificazioni, alla riproduzione di discorsi stereotipati e vittimizzanti, pronunciati, a volte, con le migliori intenzioni e, spesso, al posto delle persone interessate. Nel corso degli anni, ho preso le distanze dalle metafore sulle radici o i rizomi che spesso fungono da base per la ricerca in materia di migrazione. Per continuare con la metafora, non si può che constatare che questo approccio favorisce riflessioni terrene, persino sotterranee, mentre una metafora aerea è molto più adatta a rappresentare la circolazione delle persone, ma anche delle idee. È particolarmente adatta allo studio dei giornali anarchici pubblicati in contesti migratori, i cui fogli viaggiano praticamente in tutto il mondo e la cui esistenza è spesso intimamente legata ai percorsi delle anarchiche e degli anarchici migranti che li producono. Grazie a questi giornali, le persone e le idee si avvicinano e si confrontano.
Un’altra operazione che deriva dalla visione stereotipata della questione migratoria, e spesso ripresa anche negli studi sull’anarchismo, consiste nel separare le migrazioni “politiche” dalle migrazioni “economiche”. Anche queste categorie sono artificiali, per molte ragioni che emergono quando si studiano i percorsi degli editori e delle editrici dei giornali. Queste persone, spesso costrette a migrare a causa del loro impegno politico, in un contesto di rappresaglie ed espulsioni, si trovano il più delle volte ad affrontare le stesse problematiche (alloggio, lavoro, lingue di comunicazione, ecc.) di qualsiasi altro migrante.
L’altro elemento che spesso introduce una distorsione negli studi sulla migrazione è il concetto di identità. Infatti, per quanto essa possa essere fluida, flessibile, plurale, il fatto di considerare il fenomeno migratorio attraverso il prisma di una riflessione orientata dalla questione dell’identità tende a fissare un modello a cui tutte le persone migranti dovrebbero conformarsi, mentre è facile constatare che le tappe del percorso migratorio si declinano in modalità sempre nuove. Questa discussione sull’uso del concetto di identità fornisce una buona base di riflessione sulla questione del rapporto con il paese d’origine e, di conseguenza, sulla questione della definizione da dare al nazionalismo e all’internazionalismo, che non ha mancato di dividere e forse divide ancora le correnti anarchiche. Senza dubbio anche su questa questione è più pertinente parlare non di sguardo anarchico, ma di sguardi anarchici sulla storia.