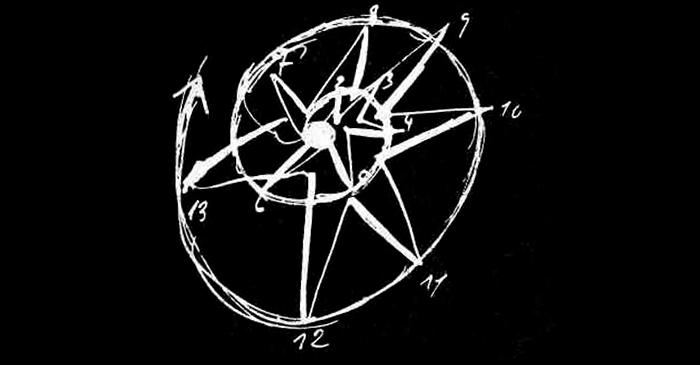Intervista a Jacques (Jacky) Toublet raccolta a Parigi nel novembre del 1997
Estratto dell'intervista tradotto in italiano
Di mestiere sono un correttore di bozze, o meglio lo ero, essendo attualmente in pre-pensionamento. Nel '68 lavoravo come correttore presso l’Imprimerie Municipale di Parigi ed ero delegato del personale. Per le persone che all'epoca – nel '68 avevo 28 anni – lavoravano nel settore industriale (come la tipografia), il Maggio '68 è stato un fatto straordinario nel senso letterale del termine, cioè inatteso. Solo più tardi abbiamo capito, riflettendo sul periodo, che alcuni eventi avevano preparato il ’68, e più precisamente la grande effervescenza del movimento studentesco, che abbastanza curiosamente era perlopiù vista dal movimento operaio come un’agitazione un po' sterile e senza avvenire. E se c'era simpatia verso quelli che contestavano l'invasione americana del Vietnam (era questo uno degli elementi forti intorno ai quali si erano formati i gruppi studenteschi), molte persone ritenevano che, al di fuori di questo aspetto umanitario, il movimento studentesco – assai poco conosciuto d'altra parte – non presentava alcun interesse. È solo nel corso del mese di maggio cha molti lavoratori si sono mobilitati, e più precisamente a partire da metà maggio quando c’è stato quel grandioso movimento (ed è inutile che vi racconti la storia): quella grandissima manifestazione cui ha partecipato circa un milione di persone (cosa che non si vedeva a Parigi dalla Liberazione). A quel punto molti lavoratori, più o meno politicizzati, hanno cercato di avviare una vasta mobilitazione in vista di uno sciopero generale in grado di abbattere il gaullismo. Ecco, grosso modo, il lato puramente politico dell'affaire dal punto di vista degli eventi. In seguito, naturalmente, i diversi protagonisti politici sono entrati in gioco, ma è in questo modo che le cose sono state viste.
Si può dire che il 1968 sia stata una rivoluzione? Non si può dire nel senso proprio del termine: non è stata una rivoluzione; non c'è stato uno sconvolgimento politico e sociale; c’è però stata una specie di mutazione della società, uno sconvolgimento delle mentalità innescato da quegli avvenimenti.
Quali ne erano le caratteristiche? Una prima di tutto: un cambiamento politico molto importante, ovvero l'indebolimento del Partito Comunista e, in particolare, della sua immagine. Il PC non era più l'elemento rivoluzionario, l’elemento portatore d'avvenire. Anzi, era diventata un'organizzazione conservatrice e corporativa. Così ormai lo vedeva la gente. Io allora ero già nel movimento libertario da qualche anno e quindi avevo già un'opinione politica sul PC, ma questa era l'opinione generale della maggioranza dei lavoratori (quanto meno di quelli che ho conosciuto): per loro, il PC era “timoroso”.
Forse si è conclusa in quel momento la messa in discussione del comunismo che, quanto meno in Francia, era cominciata dopo i fatti di Budapest del 1956, quando per la prima volta l'opinione pubblica francese aveva assistito in diretta alla repressione di un popolo in rivolta da parte di uno Stato comunista. Ed era stato terribile, per i progressisti francesi, veder infrangersi le loro speranze nell'Unione Sovietica, A mio avviso, ma è appunto un'opinione personale, nel 1968 ciò che restava ancora di quella illusione è completamente scomparso, anche riguardo allo stesso Partito comunista francese. Pur essendo i sovietici ad essere messi in discussione, i comunisti francesi – nonostante ostentassero una relativa indipendenza – vennero a quel punto visti come conservatori e timorosi.
Ciò ha cambiato ovviamente molte cose, specie tra la gioventù militante che – in generale – non si è più impegnata nel PC ma ha dato vita a un movimento chiamato “ultrasinistra”. Ma queste sono cose note e non è necessario dilungarsi.
Quali sono stati i punti di frattura importanti? C’è stata frattura politica? Io direi che c’è stata soprattutto una frattura sindacale. L'abilità tattica dei vertici della CFDT [Confédération française démocratique du travail] e il forte impegno personale di un certo numero dei suoi dirigenti –per esempio Eugène Descamps – hanno fatto sì che tutta una parte della gioventù operaia del '68 sia entrata nella CFDT e l’abbia rinnovata in maniera importante. Questo perché la CFDT era stata l'unica centrale sindacale a non condannare il movimento studentesco, come invece aveva fatto la CGT [Confédération générale du travail] che, vi ricordo, aveva tacciato Dany Cohn Bendit di essere un “anarchico tedesco”, cosa che – nello spirito del PC – senza dubbio rappresentava un doppio temibile insulto! Ma l’attacco scatenò l’effetto contrario: il PC – internazionalista, per la fraternità tra i popoli, per l’internazionalismo proletario… – non avrebbe mai dovuto esprimersi in quei termini e così l’insulto gli si ritorse contro.
Ma torniamo a quella rottura nei costumi che è stato un tratto caratteristico dell’epoca. Il quotidiano ''Libération'', peraltro nato in seguito al movimento del '68, ha pubblicato anni dopo le foto di alcuni sessantottini qualunque: prima e dopo il ‘68. Le facce erano ovviamente cambiate. Ma anche le loro vite erano cambiate. Quelli sposati hanno spesso divorziato. C’è stata nella società francese una specie di aspirazione alla liberta, compresa la libertà sessuale, compresi i tentativi di vivere altrimenti la coppia monogama, il tentativo di costituire delle comunità di persone che vivevano negli stessi appartamenti ecc. Tutto questo è durato almeno fino al 1980 e ha accompagnato l’impegno militante in varie situazioni, per esempio nella CFDT, ma un po’ ovunque c’è stata una grande combattività, ci sono stati molti scioperi… insomma, conoscete la storia.
Uno degli slogan – ed è una delle questioni da affrontare – più celebri è stato: “L'immaginazione al potere”. Molto noto anche: '“Sotto il selciato, la spiaggia”. Insomma, l'idea dell'immaginazione al potere, al di là del rimando ai surrealisti, è stata un’affermazione che ha fatto emergere un certo numero di concezioni, di modi di vedere le cose e di vivere, diffuse tra le persone impegnate nel movimento. Un approccio generale che si poteva riassumere nell'idea: “il mondo cambierà”.
In tanti all’epoca pensavano che il mondo sarebbe cambiato, non dico fino a una mutazione delle leggi scientifiche, ma quasi… Il marxismo-leninismo “alla maniera del '68”, cioè un marxismo-leninismo che avrebbe certamente provocato un forte mal di testa a Lenin stesso, era qualcosa di folle. Nel loro giornale, “Tout”, era riportata una concezione sul cambiamento del mondo che era quasi religiosa. Spero di non essere mal interpretato, ma in quella concezione c’era qualcosa che ricordava il millenarismo cristiano: il ritorno di Cristo sulla Terra che avrebbe cambiato gli uomini, la condizione umana. Ed è stata questa, senza dubbio, l'illusione più grave e più politicamente drammatica del '68. Perché ovviamente le leggi scientifiche non sono cambiate e la specie umana è restata la stessa, e dunque le disillusioni sono state all'altezza delle speranze un po' mitologiche che erano state avanzate. Il che ha fatto rifluire abbastanza rapidamente il movimento, che è stato subito recuperato dai riformisti, cioè da quelli che hanno dirottato questa dinamica sociale verso le elezioni, verso il Programma comune social-comunista, verso il governo della sinistra, al potere dieci anni dopo.
Nondimeno, c’è una caratteristica di quel periodo che è piuttosto difficile cogliere perché ha un lato magico: sì, perché è magico che – di colpo – gli individui rifiutino la condizione umana e cerchino, sotto un influsso onirico, di superarla, con tutte le difficoltà che ciò comporta. Il contraccolpo più grave è stato quando è riapparsa la realtà quotidiana, il lavoro, la disoccupazione… Lo slogan “Boulot, dodo, metro” (lavoro, nanna, metropolitana) ben riassume, insieme ad altri simili, la tristezza di un modo di vivere che continua nello stesso identico modo. Insomma [come scrive Camus nel Malinteso]: “Sapete, la vita passata a guadagnarsela, è vita perduta”.
Questo periodo, quindi, si accompagna a grandi speranze e aspettative diffuse tra quanti sono direttamente impegnati nel movimento, ma anche – è utile ricordarlo – tra le centinaia di migliaia di persone che lo condividono in tutta la Francia, e non solo nei grandi centri industriali.
È altresì vero che in parallelo c’è stata una propaganda ferocemente contraria, portata avanti dalla destra nelle piccole città e nei paesi, che presentava la Parigi del '68 come la Parigi comunarda del 1871, dove ci si sparava addosso, ecc. Una versione decisamente esagerata che vale solo come aneddoto. Ma sicuramente quelle speranze, quelle aspettative, hanno innescato le successive disillusioni, e questa è stata senza dubbio una delle ragioni che hanno permesso alla destra politica e alla sinistra riformista, che si stava ricompattando in quel momento, di recuperare il movimento, e nel secondo caso di sospingerlo verso il Programma comune e le elezioni del 1981, quando Mitterrand diventa presidente della Repubblica, con tutto ciò che abbiamo conosciuto dopo. Il '68 ha quindi a suo modo contribuito a rimettere in sesto la corrente riformista francese, che si era molto indebolita dopo la guerra d'Algeria.
Il movimento del ’68 si è anche distinto per una serie di slogan. Molti esprimevano un certo lassismo verso la vita, e molti rievocavano l’approccio situazionista. Dal mio punto di vista, questo modo di vedere le cose ha molto indebolito la corrente che cercava di costituire delle organizzazioni rivoluzionarie. Infatti, un certo numero di sessantottini e di militanti più anziani pre-'68 hanno cercato, in più direzioni, di ricostituire quello che era il movimento rivoluzionario francese, quasi scomparso dagli anni Cinquanta.
Ci sono state tre grandi ramificazioni: le varie formazioni trotskiste, il movimento maoista, molto dinamico ma anche molto confuso, e il movimento libertario. Cito in particolare il movimento maoista perché è stata una specie di aberrazione storica, qualcosa di assurdo. I vari partitini, composti da giovani che perlopiù provenivano dal cristianesimo o dal PC), avevano sussunto, basandosi su ciò che si sapeva e che veniva detto sulla rivoluzione culturale cinese, una concezione politica ed economica che metteva insieme l’origine cristiana o stalinista del loro corpus teorico – spesso mischiate tra loro dato che passavano sovente da una formazione all'altra – e quell’afflato antiautoritario che si diceva esistesse nella rivoluzione culturale cinese (abbiamo poi saputo che si trattava di un fraintendimento, di una menzogna). Comunque sia, questo miscuglio assolutamente sorprendente di autentiche preoccupazioni antiautoritarie ha influenzato il funzionamento sia delle strutture organizzative maoiste (in genere sul breve periodo) sia dei rapporti interpersonali: nelle lotte, nella propaganda che portavano avanti, c'era una vera preoccupazione antiautoritaria. Per cui, indipendentemente dall’ideologia proclamata, dal distintivo di Mao sull'uniforme blu, i maoisti erano in fondo degli anarchici dal punto di vista del funzionamento individuale e organizzativo. Resta inteso che in realtà c’erano – come si è poi saputo – strutture e gruppi dirigenti, un po' dissimulati, che manipolavano il movimento. Il quale, d'altra parte, è scomparso molto rapidamente. Infatti, quando è emersa la verità sulla Cina maoista, grazie a scrittori come Simon Leys, autore del libro Gli abiti nuovi del Presidente Mao [Antistato, Milano, 1977], questa specie di aberrazione storica, che dipendeva da numerosi fattori, ha portato a una catastrofica scomparsa di quanti si richiamavano al maoismo, e più in generale al marxismo-leninismo.
In conclusione, se in campo riformista sono stati i socialisti a rinascere sulle rovine del '68, in campo rivoluzionario sono stati indiscutibilmente i trotskisti a trarne i maggiori vantaggi, e questo perché il movimento esisteva già da alcune decine d’anni. Ben prima degli avvenimenti del ‘68, si erano infatti costituiti alcuni gruppi trotskisti che avevano una certa consistenza non solo nelle università ma (a seconda dei gruppi) anche nella classe operaia o tra i gli impiegati pubblici. In particolare gli aderenti al Partito Comunista Internazionalista erano riusciti a mantenere nei decenni precedenti una struttura molto più consistente di quella del movimento libertario dell'epoca, che era – come constatavo all’epoca – estremamente debole.
È a partire da quei nuclei, cresciuti intorno alla J.C.R. [Jeunesse communiste révolutionnaire], alla F.A.R. [Fédération Action Révolutionnaire] e a Lutte Ouvrière (che allora si chiamava Voix Ouvrière), che c’è stata un’espansione considerevole, tanto da far aderire una parte notevole della gioventù alle loro parole d'ordine.
Vanno inoltre ricordati due eventi che hanno marcato a fondo quel periodo. Il primo è la morte di Pierre Overney, che in certo modo ha segnato la fine dell'ultrasinistra. Dopo che Overney è stato ucciso davanti alla Renault, per ragioni che non so spiegare al suo funerale tutte le illusioni sono improvvisamente evaporate. C’erano state altre morti, ma questa era stata particolarmente sordida: un giovane abbattuto in quel modo davanti a una fabbrica, proprio quando la società sembrava, malgrado tutto, sulla via della pacificazione. È stato quindi una sorta di choc che ha fatto evaporare ogni illusione: in quel momento il mondo reale è apparso in tutta la sua brutalità. Comunque sia, è stato allora che la sinistra istituzionale si è trasformata ed è diventata quello che è ancora oggi: contro l'estrema sinistra, che cercava in parallelo di lavorare nel movimento operaio, tra la popolazione. E così quel grande movimento di sinistra che stava montando si è fermato con Overney.
Il secondo evento è stata la messa al bando della L.C.R. [Ligue communiste révolutionnaire] in seguito ad una manifestazione diretta all'ambasciata degli Stati Uniti. In quell’occasione la L.C.R. scioglie il suo servizio d'ordine, il gruppo che era stato costituito dalla J.C.R. [Jeunesses communistes révolutionnaires], e decide di diventare un’organizzazione politica “adulta”. Ed è da quel momento che a mio avviso è iniziato il loro declino. Rifiutando di assumere la violenza dei giovani operai, rifiutando di sostenerla, hanno infranto in qualche modo la loro speranza storica. Se avessero continuato – è un'opinione personale – avrebbero potuto diventare davvero un'organizzazione di un certo peso nella società francese, mentre il fatto di voler diventare un'organizzazione politica li ha resi un piccolo partito comunista qualsiasi. Krivine che scimmiottava Marchais, insomma, e tutto è diventato banale.
Cosa si può dire del movimento libertario? Prima di tutto, direi che questo movimento era straordinariamente debole, almeno nei centri industriali, ed era stranamente svalutato, cioè l'anarchismo non era più presente da nessuna parte. Forse un po’ nella letteratura. Insomma, non c'erano né libri, né militanti. A Parigi esistevano due o tre gruppi della Fédération Anarchiste, il gruppo Noir et Rouge di cui aveva fatto parte Cohn-Bendit, e il gruppo Gaston Leval di cui faceva parte Christian Lacombe, un militante di grande valore (anch’io facevo parte di questo gruppo). E questo era tutto.
L'influenza di un certo numero di studenti libertari – Cohn-Bendit, [Jean-Pierre] Duteuil… che peraltro sono ancora presenti –diede impulso al movimento, appiccando il fuoco: sono stati la scintilla che ha fatto divampare l’incendio. E man mano che il movimento si sviluppava (grazie anche agli scioperi), il numero delle bandiere nere aumentava sempre più, mentre all’inizio, nei primi giorni, le bandiere nere erano quasi assenti.
Quelli che andavano in giro con le bandiere nere, le centinaia di persone che se ne andavano in giro con le bandiere nere, erano anarchici nel senso in cui noi lo intendiamo? Avevano un'idea di quello che significa la rivoluzione libertaria, i progetti di ricostruzione della società, l'autogestione, la collettivizzazione della produzione, ecc.? Erano a conoscenza di tutto questo? Ne dubito, ma erano attirati, credo, da un'ideologia non svalutata, mentre tutte le altre – a parte un po’ i trotskisti – lo erano. La gente si era impadronita di questa specie di rivolta! Vi ricordo che si è trattato, malgrado tutto, del più grande sciopero generale del mondo. Non si era mai visto al mondo uno sciopero generale così importante e così pacifico, perché in definitiva ci sono stati solo pochi scontri e pochi morti, se si pensa a cosa sarebbe potuto succedere. Ci sono stati dei colpi d’arma da fuoco, ma solo qua e là. La mattina, dopo i fatti, dopo essersi scontrati con i poliziotti, si vedevano nei bistrò le tracce delle pallottole, ma si è trattato di poca cosa. Sarebbe stato ben diverso se si fosse presa la decisione di reprimere e di sparare con le mitragliatrici.
Comunque sia, questo movimento libertario spontaneo, senza dubbio legato più ai simboli e alle forme che alla sostanza, si è sviluppato e il movimento anarchico è rinato. È riapparso così. In modo sorprendente. Grazie al movimento del '68, l’anarchismo francese è ridiventato vivace e importante. Può sembrare strano, ma le persone conosciute dopo si dividevano in qualche modo tra ante '68 e post '68. Io facevo parte degli “ante” insieme a qualche altra decina, ed eravamo quelli che avevano avuto una preparazione teorica Nel mio gruppo, il Gaston Leval, ricevevamo regolarmente delle “iniezioni” di teoria: non si poteva non conoscere la vita di Kropotkin! Così c’è sempre stato una specie di iato tra quelli che conoscevano la teoria e quelli che erano diventati anarchici nelle manifestazioni e negli scioperi. Ho conosciuto parecchi compagni del settore industriale che erano diventati anarchici negli scioperi, nell’azione, e quasi senza saperlo. Ma un giorno hanno visto passare una bandiera nera e si sono detti: “Mi piace”. In seguito hanno appreso delle cose e a partire da quel momento si è ricominciato a stampare i classici dell'anarchismo.
Per fare un esempio in ambito editoriale, Roger Haguenauer, un compagno di vecchia data (all'epoca aveva 65-70 anni) che non si diceva anarchico ma che era sicuramente libertario, membro di Révolution prolétarienne e maestro elementare, era stato contattato, mio tramite, da una grande casa editrice francese per scrivere un pamphlet sulla rivoluzione. Gli avevano chiesto di spiegarla in maniera semplice, in 50-60 pagine, in modo da far capire che cos’era. E lui aveva cominciato a scrivere un libro, a partire dalla Prima Internazionale, riprendendo le dichiarazioni e le parole d’ordine dell'Internazionale, una per una, e mettendo accanto una spiegazione in termini moderni in modo che la gente capisse. Quando era arrivato alla Comune di Parigi il progetto venne improvvisamente bloccato perché tutti si erano resi conto che il movimento si stava esaurendo, che era stato recuperato. A distanza di sei mesi dagli avvenimenti, tutte le case editrici lo avevano capito, e quindi il progetto fu interrotto. Ma è stato comunque importante che una grande casa editrice, Flammarion, che non è né progressista né rivoluzionaria, volesse stampare – per ragioni commerciali – 100-200.000 copie di un libro del genere. Mostra quanto fosse forte l'interesse e fino a che punto il movimento avesse influenzato gli animi, perfino quelli dei commercianti, che si dicevano: “Conviene investire nella rivoluzione” (e per rivoluzione intendevano l'anarchia, non Trotski, non c’era affatto Trotski dietro). È state un momento molto breve, come dicevo, poi c’è stato una specie di riflusso che ci ha portati alla situazione attuale.
Uno degli argomenti di cui si è discusso spesso è stato: il '68 ha avuto dei discendenti? e chi sono i suoi eredi politici e ideologici? Io ritengo che il Maggio '68 sia stato molto importante perché ha mostrato la capacità della gente di mettere in discussione la forza degli Stati. È un fatto cruciale, ed è così che è stato percepito dalla gente che l'ha vissuto. E questo nonostante gli Stati siano estremamente potenti. Ma per qualche giorno è stato possibile farli vacillare. Lo Stato continuava a esistere, ma aveva perso il contatto con la popolazione, e perfino i collegamenti tra alcuni settori dello Stato stesso erano stati interrotti: i telefoni non funzionavano più perché i comitati di sciopero li bloccavano, ecc. È nota la storia del prefetto che voleva telefonare a non so chi e il centralinista gli disse: “Un attimo, domando al comito se posse passarle il suo interlocutore”. Pare che il prefetto in questione non si sia ancora ripreso!
Altro esempio: le stesse C.R.S. [reparti celeri della polizia francese] si sono dovute riorganizzare in modo da essere autonome. Nei loro convogli avevano riserve di cibo e bevande, e potevano perfino dormirci dentro. Si erano resi conto che il clima generale era talmente ostile nei loro confronti che rischiavano di non potersi più approvvigionare. D’un tratto, per loro era diventato difficile sopravvivere in un paese che appariva sull’orlo di un’insurrezione, anche se più che assalti diretti si trovavano a fronteggiare un paese che si era ritratto. Abbiamo così assistito all’introduzione delle cucine mobili nei convogli C.R.S., in modo da potersi spostare attraverso il paese senza dipendere da altri. Questo valeva anche per i sistemi di telecomunicazioni. A tal proposito, non solo avevano messo a punto un proprio sistema radio, ma per un periodo avevano anche schierato dei reparti intorno alla Maison de la Radio perché temevano che qualche movimento potesse prendere possesso delle telecomunicazioni interrompendo uno dei canali più importanti per il controllo della popolazione.
Quello che sicuramente posso dire è che c’è stata, da parte della mia generazione, una grande presa di coscienza. È possibile che anche le generazioni precedenti, quelle che avevano conosciuto il 1936 o il 1945, si fossero rese conto che lo Stato è solo una costruzione e come ogni costruzione può essere indebolita, distrutta, smantellata. Ma di certo per noi sessantottini questa è stata una conquista cruciale: davanti a una massa enorme di persone, lo Stato può essere affrontato a forze pari.
E poi c’è un secondo elemento cruciale, quanto meno per me. All’epoca molti dicevano: “Il movimento rivoluzionario è morto. Il movimento rivoluzionario attivo, quello che scende nelle strade, è morto. Bisogna trovare altre vie”.
Anche molti anarchici all'epoca dicevano: “Bisogna trovare strade diverse rispetto allo scontro frontale. La capacità militare delle forze armate è decisamente superiore a quella delle organizzazioni rivoluzionarie, e dato che la popolazione non scende più nelle piazze, bisogna trovare altre strade”. Queste cose venivano dette fino all’aprile ‘68, ma poi, all’improvviso, ci siamo ritrovati davanti un movimento gigantesco che ha mostrato con i fatti che quel discorso era sbagliato, pessimista e fuorviante. È ancora possibile, nella società industriale avanzata, che masse di persone si mobilitino. Certo, si tratta di momenti brevi, e tuttavia forti, ma soprattutto va ribadito non si possono aspettare quei momenti per cominciare a chiedersi cosa bisogna fare. Nondimeno questa possibilità esiste e va costantemente costruita. Ed è appunto in questa prospettiva che dobbiamo vedere movimenti come quello del 1986, quello del novembre-dicembre 1995, quello dei ferrovieri e tanti altri. Tutto ciò mostra che le persone hanno capito e si ricordano – attraverso la trasmissione orale o non so cosa – che è possibile far indietreggiare lo Stato, affrontarlo alla pari. Sono questi gli eredi del ’68, è questo il lascito politico del '68 che noi dobbiamo portare avanti.