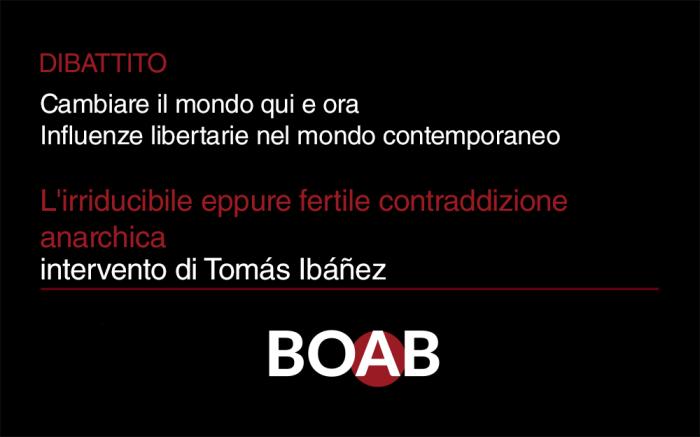L'irriducibile eppure fertile contraddizione anarchica
di Tomás Ibáñez
Certo, potremmo anche coltivare il desiderio che l'anarchismo sia dotato di una solida coerenza interna e rimpiangere il fatto che racchiude in sé delle contraddizioni, ma questo vorrebbe dire allontanarsi da ciò che costituisce la sua unicità e la sua ricchezza. Per nostra grande fortuna, l'anarchismo è contraddittorio e imperfetto, ed è proprio la consapevolezza della sua imperfezione a spiegare l'assenza di dogmatismo, la mancanza di rigidità, l'apertura al cambiamento, la capacità di autocritica e la disponibilità costante a correggere le proprie sbavature. Perché non è la convinzione di essere in possesso della verità quel che permette di rinnovarsi mettendo in discussione ciò che consideriamo acquisito, bensì l'incertezza, il dubbio e la consapevolezza che le nostre posizioni sono legate alla fragilità umana.
Una delle principali contraddizioni dell'anarchismo risiede nell'apparente incompatibilità tra due elementi che sono tuttavia essenziali per definirlo nella sua unicità, di modo che per via della loro necessaria coesistenza l'anarchismo stesso si ritrova in una situazione letteralmente dilemmatica.
Da un lato, si tratta dell'esigenza etica di non generare rapporti ed effetti di dominio nella lotta contro il dominio stesso, perché allora l'anarchismo si convertirebbe nell'antitesi di ciò che pretende di essere. Questa esigenza deriva dall'insistenza anarchica sulla necessaria corrispondenza tra il dire e il fare, tra i fini e i mezzi, poiché i mezzi che utilizziamo per raggiungere i fini che perseguiamo non possono mai essere in opposizione rispetto a questi stessi fini. Ad esempio, non si può lottare per la libertà con mezzi che ne sono la negazione o, per dirlo in termini più attuali, i mezzi devono sempre prefigurare i fini che pretendono di raggiungere o, almeno, non devono contraddirli.
Per evitare perifrasi userò un neologismo che mi sembra piuttosto utile: l'anarchismo deve essere indominante, nel senso che per essere in accordo con i propri valori deve essere libero da effetti di dominio: in altre parole, o l'anarchismo è indominante, oppure tradisce se stesso diventando fonte di dominio.
D'altra parte, in quanto movimento politico basato su un insieme di valori e idee, l'anarchismo non può rinunciare alle caratteristiche costitutive che lo rendono tale. Ad esempio, non può rinunciare alla sua dimensione utopica, a perseguire progetti di emancipazione, a intraprendere azioni prefigurative, a orientare le lotte in base ai propri valori e principi, insomma a tutta una serie di elementi che gli sono consustanziali, ma che gli impediscono di essere indominante poiché producono effetti di dominio.
Il dilemma è senza via d'uscita perché, per sua stessa costituzione, l'anarchismo deve essere al contempo indominante e non indominante, eppure per questa stessa ragione derogare sempre, in entrambi i casi, alla condizione anarchica.
Non c'è un tertium quid, e dobbiamo riconoscere che l'anarchismo è intrappolato in una sorta di aporia costitutiva: o è indominante al fine di essere anarchico, ma allora cessa di essere anarchico perché è costretto a rinunciare a gran parte di ciò che costituisce l'anarchismo; oppure, per preservare l'essenziale dell'anarchismo, non è indominante e tradisce quindi ciò che costituisce una condizione sine qua non dell'anarchismo. Sono due esigenze contraddittorie, che definiscono due modi di essere letteralmente incompatibili nello stesso mondo, che possono esistere simultaneamente solo in modo inevitabilmente contraddittorio, in stretta opposizione reciproca.
Eppure, come se si trattasse di uno strano antagonismo simbiotico tra ciò che si trova allo stesso tempo in una flagrante opposizione e in una stretta alleanza, questi due aspetti si fondono in un'entità composita che non può che essere simultaneamente indominante, priva di effetti di dominio, e dominante, in quanto generatrice di tali effetti. È proprio nel mantenimento di questi due aspetti in costante tensione che sta la singolarità e la ricchezza dell'anarchismo. Questa contraddizione pulsa nel cuore dell'anarchismo e non la si può eliminare senza cancellare l'anarchismo stesso, perché non rimarrebbe altro se non una sola delle sue due facce, e si dà il caso che, prese isolatamente, nessuna delle due corrisponde all'anarchismo.
Amedeo Bertolo scriveva, già molto tempo fa, che l'anarchismo allo stato puro era come una bevanda troppo alcolica per poter essere gustata senza provocare un certo malessere, di modo che per renderla più facilmente assimilabile bisogna abbassarne la gradazione. Allo stesso modo, l'anarchismo indominante è una figura troppo austera e troppo emaciata per poter costituire una compagnia piacevole, e deve accettare di non essere pienamente indominante per rendersi conviviale, affascinante e persino entusiasmante.
L'aria che spira sulle alte vette dove alberga l'anarchismo indominante è senza dubbio la più tersa, la più priva di fattori inquinanti, ma è anche troppo povera di ossigeno per poterci vivere comodamente, di modo che dobbiamo scendere in zone dove l'aria è meno pura ma più respirabile, anche se questo ci obbliga a fare i conti con la purezza dell'anarchismo e a ritrovarci con un anarchismo dal volto umano, per non dire troppo umano.
Senza entrare per il momento nella delicata questione se sia davvero realmente possibile che l'anarchismo sia del tutto indominante, resta comunque il fatto che è abbastanza facile spiegare e comprendere il senso e le ragioni di questa esigenza etica.
È invece molto più difficile comprendere perché un insieme di attributi propri a cui l'anarchismo non potrebbe rinunciare senza rinnegare se stesso, siano spesso gravidi di effetti di dominio. Per cogliere questi effetti occorre fare una breve digressione storica e immergerci, sia pure superficialmente, nell'arché e nell'anarché della filosofia greca. Intendere arché come presenza ed esercizio del potere, e anarché, o anarchia, come assenza di potere, ha significato dimenticare che l'arché era una combinazione di potere e principi primi fondamentali. Questi principi erano essi stessi induttori di effetti di potere, poiché, essendo posti all'inizio, subordinavano tutto ciò che seguiva. L'anarché, l'anarchia, era dunque assenza di potere, certo, ma anche assenza di principi di fondo, ed è questo che, secondo Aristotele, trasforma l'anarchia nel peggior pericolo che possa minacciare una società.
Prendere in considerazione questa componente dimenticata dell'anarchia e approfondire la questione dei principi permette di delineare una forma di anarchismo che mi sembra opportuno definire, per il momento, «anarchismo non fondazionale». È proprio riflettendo sugli aspetti del dominio messi in evidenza dall'anarchismo non fondazionale che è possibile comprendere perché le componenti più comuni, e spesso più attraenti, dell'anarchismo contraddicono l'esigenza dell'indominanza.
Tra queste componenti troviamo le utopie che alimentano i desideri e l'immaginazione, i principi da rispettare, i valori da difendere, gli obiettivi verso cui avanzare ecc. Come si può essere anarchici senza far propri tutti questi elementi, colorandoli delle sfumature dei propri anarchismi prediletti? E tuttavia, come assumerli senza violare il rispetto dell'autonomia propugnato dall'anarchismo?
Il rispetto dell'autonomia, infatti, presuppone il rifiuto di qualsiasi tentativo di introdurre elementi teorici estranei alle lotte, come ad esempio i principi guida, le forme ammesse o gli obiettivi da perseguire. Tutto ciò deve nascere dal seno delle lotte stesse, senza che nulla le orienti o le diriga dall'esterno, perché l'autonomia non può essere raggiunta se non attraverso il suo stesso esercizio, e questo sottrae legittimità a qualsiasi intervento esterno al processo autonomo stesso, a dimostrazione dell'inutilità e del carattere liberticida di ogni avanguardismo.
Certo, l'anarchismo ha sempre contestato che la teoria – il luogo in cui risiedono i principi, non dimentichiamolo – avesse qualche legittimità per tracciare i percorsi della pratica e che quest'ultima dovesse sottomettersi docilmente alle sue indicazioni.
È vero che contro queste concezioni l'anarchismo ha sempre valorizzato le pratiche rispetto alla teoria, stabilendo un nesso di causalità reciproca tra queste due entità, nella consapevolezza che le pratiche producono elementi che si incorporano nella sfera teorica modificandola e che da lì si ripercuotono sulle pratiche modificandole a loro volta. Detto questo, l'anarchismo non fondazionale dà un ulteriore giro di vite rafforzando l'importanza decisiva delle pratiche e, nei termini dell'«a priori pratico», sottolinea il primato che l'anarchismo deve accordare alla pratica.
Una volta svuotata l'anarché del potere e dei principi che appartengono all'arché, la prassi umana si trova privata dei lumi della teoria necessari a orientarsi e non trova fondamento se non su se stessa, senza possibilità di rivolgersi a principi esterni, cioè a principi che non emanano immediatamente da ciò che le pratiche stesse creano e sviluppano in ogni situazione e in ogni lotta particolare.
Vuol dire allora che le lotte anarchiche contro il dominio devono essere scevre di principi? No, nient'affatto, ma sono riconosciuti come principi legittimi solo quelli che si forgiano nel cuore di queste lotte, quelli che sono inerenti alle situazioni concrete e non sono proiettati sulle pratiche antagoniste dall'alto di teorie esterne alla situazione. Non obbedire ai principi non significa avventurarsi alla cieca nella vita ignorando ogni principio, ma solo che i principi assunti non sono trascendenti, universali, immutabili o assoluti, bensì contingenti e immanenti a pratiche socialmente e storicamente situate.
Detto questo, l'anarchismo non fondazionale non comporta solo l'assenza di principi guida situati nella sfera sovrastante della teoria, ma anche l'assenza di finalità prestabilite il cui raggiungimento dovrebbe guidare le pratiche. Si tratta infatti di procedere senza l'autorità dei principi, ma anche in assenza di telos. Cioè senza subordinare le pratiche all'esigenza di raggiungere obiettivi definiti al di fuori delle pratiche stesse.
Quando l'anarchismo non fondazionale stabilisce che le pratiche non debbano essere guidate dalla volontà di raggiungere determinati obiettivi, non mette in discussione il fatto che debbano essere propositive, perché si tratta pur sempre di azioni animate da intenzioni, il che le distingue da semplici automatismi comportamentali. Si limita a sostenere che il perseguimento di un obiettivo prestabilito non deve essere il motore dello sviluppo di una pratica, ma che questa deve elaborare il suo obiettivo nel corso del suo sviluppo, in funzione delle circostanze sempre contingenti che si presentano in ogni situazione concreta. Quindi, degli obiettivi da raggiungere? Sì, certo, ma che non sono definiti preventivamente, al di fuori delle situazioni concrete e singolari, né a partire da un piano altro da quello della pratica stessa nel corso del suo sviluppo.
Per dare un esempio di cosa significhi assenza di telos possiamo richiamarci alla visione dell'anarchismo come strumento per fare cose come, ad esempio, decostruire ovvietà ereditate, attaccare i dispositivi di dominio, costruire spazi e relazioni libere da rapporti gerarchici e così via, uno strumento utile tra le altre cose e nella misura del possibile ad anarchizzare il mondo.
Non si tratta però di anarchizzare il mondo in risposta a un progetto, formulandolo come un obiettivo da raggiungere, bensì come un effetto, come una conseguenza dello sviluppo delle pratiche anarchiche che sono fine a se stesse. Queste pratiche non si sviluppano con l'obiettivo di anarchizzare il mondo, ma lo anarchizzano di fatto come risultato del loro stesso sviluppo, del loro scontro con il dominio. Si tratta, insomma, di anarchizzare il mondo e non di garantire la vittoria dell'anarchismo, si tratta di mettere in atto pratiche che sono anarchizzanti di per sé. Ad esempio, il mondo si cambia costruendo reti orizzontali di libera associazione, ma queste reti non si creano per cambiare il mondo, bensì perché racchiudono in sé i valori di un mondo nuovo, estraneo all'arché.
Per anarchizzare il mondo, per cambiarlo in direzione anarchica, non bisogna volerlo cambiare, stabilendo una tabella di marcia per spingerlo in quella direzione, ma semplicemente fare cose che hanno come uno dei loro effetti questo cambiamento, e che però trovano in se stesse, e non nell'obiettivo da raggiungere, la propria finalità e il proprio valore.
Su questo punto possiamo senz'altro richiamarci a quanto diceva Max Stirner quando sosteneva che non bisogna mirare a istituire un mondo nuovo per mezzo di un progetto e di un processo rivoluzionario, ma dispiegare l'insurrezione permanente contro il mondo così com'è, resistendo al dominio e sviluppando pratiche destituenti di fronte alle istituzioni, con l'obiettivo di contrastare il dominio, non di sostituirlo con un altro modello, perché chi lo sostituisse si ritroverebbe a essere bersaglio dell'insurrezione.
Invece della rivoluzione animata dalla volontà o dal progetto di realizzare una trasformazione sociale che rovesci l'istituzione politica esistente sostituendola con un'altra, l'insurrezione permanente si limita a non accettarla, si ribella all'oppressione esistente perché la considera semplicemente inaccettabile. Di fatto, sviluppare pratiche di resistenza significa già cambiare il mondo. La resistenza è immediatamente trasformatrice di per sé, senza bisogno di essere sostenuta da un progetto di trasformazione.
A questo punto, è giunto senza dubbio il momento di avanzare una delle possibili risposte alla domanda sul modo di «avviare un'autocritica dell'anarchismo» e rispondere alla sfida che ci troviamo ad affrontare per sollevarlo dalla sua relativa stagnazione. Per parte mia, avanzo l'ipotesi che se l'anarchismo non si sviluppa in modo più significativo è, tra le altre ragioni, perché è colto da una certa vertigine di fronte al suo carattere aporetico.
Di fatto, rimarrà immobile finché non deciderà di affrontare la sfida posta da questa contraddizione, finché non deciderà di abbracciare l'aporia che rappresenta e di esplorare con audacia l'equivalente metaforico della faccia nascosta della luna, cioè quella che rimane nell'ombra ed è costituita dall'esigenza radicale dell'indominio. Non potrà fare passi avanti finché non deciderà di percorrere la via del necessario e impossibile indominio insita nell'anarchismo. Superare questa aporia richiede la ricerca di nuovi modi di vedere, pensare e agire che facciano saltare le cuciture dell'anarchismo.
A condizione che il nuovo tipo di totalitarismo che si sta instaurando a marcia forzata in tutto il mondo non lo impedisca, è possibile, direi addirittura probabile, che entro un tempo non troppo lontano prenda forma uno strumento che sarà realmente e pienamente indominante.
Ma non sarà più l'anarchismo, sarà qualcos'altro. Un'altra cosa che, non diversamente dall'anarchismo, si opporrà a ogni forma di dominio creando spazi e relazioni liberi dal dominio, ma che avendo superato la contraddizione interna dell'anarchismo – la sua aporia costitutiva tra l'esigenza di indominio e la sua necessaria negazione – sarà necessariamente qualcosa di diverso
[Traduzione di Andrea Carbone]